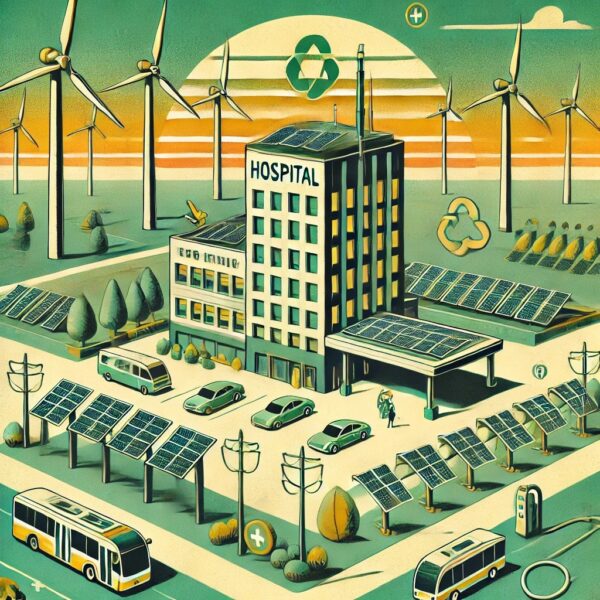Intervista a Bernard Mossé, responsabile scientifico di NEEDE Méditerranée, con François Crémieux, direttore generale dell’Assistance publique des hôpitaux de Marseille (APHM) ed Émilie Garrido-Pradalié, direttrice dell’innovazione dell’APHM.
#2 L’estensione della nozione di « salute » e i rischi che comporta
Bernard Mossé : Mi sembra, ascoltandovi, compresi i nostri scambi preliminari, in particolare sulla questione dell'attenzione ai più vulnerabili, che la nozione di salute ha preso un'estensione molto ampia in 3 o 4 decenni. Che, senza dubbio, in seguito ai lavori del filosofo Georges Canguilhem, la salute non può essere definita solo dall’assenza di malattia. Ad esempio, ciò che oggi chiamiamo salute sul lavoro va ben oltre ciò che si intendeva dire 30 anni fa.
François Crémieux : Sì, è vero. Ed è sia una vittoria che un rischio.
Da un lato, è una vittoria che è in parte legata al fatto che l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ripete con insistenza che la salute è uno « stato di completo benessere fisico, mentale e sociale », e « non consiste solo nell’assenza di malattia o di invalidità ». Con una concezione effettivamente molto più generale, quasi filosofica, e infine quasi irraggiungibile, di ciò che è la buona salute. Quindi è la vittoria di questo concetto e penso che sia una buona notizia.
In secondo luogo, è un vero rischio. Lo vediamo oggi in psichiatria, in cui l'estensione della nozione di malattia psichica è passata dalla psichiatria alla salute mentale, e dalla salute mentale al benessere, con scaffali di librerie pieni di libri sulla questione del benessere, che finiscono per farci dimenticare che tra il benessere e la schizofrenia c'è uno stato che non è chiaramente lo stesso.
Trovo quindi che sia sia una bella vittoria aspirare a vivere non solo in assenza di malattia, ma ad esempio in assenza di dipendenza quando si invecchia, in assenza di stress sul lavoro, quando si è altrimenti in buona salute somatica. È un rischio anche in termini di politiche pubbliche. Si riorientano i mezzi non verso la solidarietà tra malati e sani, ma in una sorta di dispersione delle risorse verso tutti, compresi i sani, e con forse il rischio di una perdita di solidarietà con coloro che sono realmente malati. Trovo che la psichiatria oggi ponga chiaramente questa questione. Ancora una volta, il lato positivo della concezione più globale della salute mentale verso uno stato di benessere e non semplicemente di sofferenza psichica e somatica delle malattie psichiatriche gravi, è sia la vittoria di una bella concezione ampia e olistica della salute umana, ma è anche il rischio di una perdita di attenzione e solidarietà nei confronti di coloro la cui malattia è un handicap e una forte sofferenza.
BM : Una delle conseguenze di questa estensione della nozione di salute è forse quella di far gravare tutto il peso della responsabilità sul sistema sanitario dove le questioni dovrebbero essere trattate in modo più globale da altre politiche e altre strutture, economiche e sociali? Faccio il parallelo con le questioni di educazione che rimandano ben oltre la Scuola.
F.C. : Penso ovviamente che ci siano due rischi.
Il primo è effettivamente di far gravare tutto sul mondo della salute in termini di politiche pubbliche, ma anche di formazione, risorse, competenze, ecc.
Ma c'è anche il rischio di deviare il mondo della salute verso questi argomenti. Come per la psichiatria, una delle difficoltà oggi è mantenere saldi i fondamentali, per così dire, in ogni caso sulla presa in carico delle persone la cui salute mentale è così compromessa da diventare una sofferenza invalidante: prendersi cura della schizofrenia quando è in fase acuta, delle persone che hanno tentato il suicidio, ecc. E non lasciarsi troppo deviare dalla questione del benessere.
C'è un piccolo rischio da un lato di sovra-responsabilizzare il mondo della salute e, ad esempio, di de-responsabilizzare il mondo dell'Educazione sulle questioni educative; dall'altro lato a demotivare il mondo della salute sui suoi principali problemi. Si tratta ancora una volta di trovare l'equilibrio tra una visione ampia della salute e la presa in carico efficace delle patologie che provocano le maggiori sofferenze.
B.M. : La ricerca di questo equilibrio è senza dubbio anche uno dei temi della salute ambientale?
F.C. : In modo abbastanza preciso, l'interesse crescente per le questioni di salute ambientale che emergono dal cuore dell'ospedale ci conduce abbastanza logicamente -va nella direzione della sua domanda- a uscire dall'ospedale. Perché in effetti, non appena si parla di salute in relazione all'ambiente, si è immediatamente portati a uscire, sia per interessarsi all'impatto dell'ospedale stesso sul suo ambiente sia per l'impatto delle cure. Si tratta di evitare la malattia adattandosi meglio all'ambiente. Quindi sì, ha ragione sul fatto che la salute ambientale porta anche in modo intrinseco, come la salute mentale, questa necessità di ampliare il proprio campo oltre il mondo della cura e dei professionisti della salute.
BM : Oltre alla questione della prevenzione, questo allargamento della nozione di salute non implica -è un vecchio dibattito- una responsabilizzazione maggiore dei malati stessi nei trattamenti?
F.C. : Sì, rimane un tema per ragioni che non sono direttamente collegate allo scambio che stiamo avendo, ma al fatto che la maggior parte dei malati oggi sono affetti da malattie croniche e che dovranno vivere nel miglior modo possibile e il più a lungo possibile con questa malattia. E da quando la malattia non è più solo una fase acuta che porta alla morte.
C'erano, grosso modo, fino a poco tempo fa, persone malate per le quali eravamo preoccupati e che rischiavano di morire, ma che non erano disabili. E persone disabili, in particolare la disabilità di guerra e la disabilità fisica, ma che non erano malate. Oggi c'è una sorta di continuum tra disabilità, malattia e pieno stato di benessere, tanto che si può essere in stato di benessere essendo disabili e/o malati, riuscendo a compensare la malattia o la disabilità e a vivere perfettamente felici con essa. E quindi sì, la questione dell'autonomia, e in una certa misura dell’automedicazione, di ciò che noi chiamiamo dall'ospedale « i pazienti », ma che sono anche genitori, cittadini, dipendenti, attivisti associativi, pensionati, ecc., è diventata un tema centrale. Non tanto che abbiano sempre una conoscenza scientifica della loro malattia e della farmacologia per auto-educarsi, ma in ogni caso, che possano guadagnare autonomia di fronte alla cronicità delle malattie per non dover dipendere eternamente dalla visita settimanale dal medico per sapere se prendere 1 o 3 compresse. Al contrario, vediamo anche il rischio dell'autonomizzazione e della responsabilizzazione, che può finire per essere pesante da sopportare in termini di carico mentale per persone già iper-sollicitate come genitori, dipendenti, ecc.
Vista dall'ospedale, l’equilibrio è oggi molto instabile, a seconda delle malattie, a seconda del comportamento dei curanti... Manifestamente, a volte siamo troppo presenti, a volte non abbastanza. Ho appena ascoltato l'intervento di un'attivista impegnata nell’AFM Téléthon (l'Associazione francese contro le miopatie): quando si è genitori di bambini disabili con disabilità gravi, la questione non è di essere ancora più responsabilizzati di quanto non si sia già in un mondo che globalmente aiuta poco a vivere con un bambino gravemente disabile. E quindi qui siamo nel troppo responsabilizzante per insufficienza di politiche pubbliche, di accompagnamento delle risorse associative. Al contrario, in molti altri ambiti, probabilmente, non si lascia sufficiente libertà ai pazienti. Quando, ad esempio, nel campo della nefrologia, si impongono in modo eccessivo dialisi, a mancanza di proposte a volte di metodi che lasciano più libertà: qui, siamo al contrario nella mancanza di autonomia.
Qui, come si vede in molti altri ambiti, il dosaggio da trovare è delicato per garantire il massimo di autonomia ai pazienti in relazione a ciascuna condizione di salute e al contesto di vita di ciascuno di loro.
Biografie

François Crémieux è un alto funzionario della salute il cui percorso è singolare e plurale. Laureato in economia presso le università di Parigi Dauphine e Lancaster (GB) e in sanità pubblica presso la facoltà di medicina di Parigi Diderot, dirige dal giugno 2021, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille, l’APHM. Ha condotto una lunga carriera come direttore di ospedale che lo ha portato dal centro ospedaliero Clermont dell’Oise all’ospedale di Kosovska Mitrovica in Kosovo, passando per funzioni di consigliere presso Marisol Touraine, ministra delle affari sociali e della salute e di vice alla Direzione Generale dell’APHP presso Martin Hirsch. Il suo impegno si inserisce in azioni multiformi : volontario in Bosnia negli anni '90, in piena guerra ; membro del comitato di redazione della rivista Esprit da lungo tempo ; sostenitore di un ospedale in prima linea per ridurre le disuguaglianze sociali di accesso alle cure.

Emilie Garrido-Pradalié è direttrice di ospedale incaricata dell’innovazione all’APHM. Laureata in economia teorica e applicata presso l’università di Montpellier e in informatica e sistemi informativi presso l’école des mines d’Alès, ha iniziato la sua carriera nella pubblica amministrazione all’interno della Metropoli di Montpellier guidata da Georges Frêche. È entrata nel CHU di Montpellier nel 2008 per condurre attività di gestione del cambiamento presso le risorse umane, mediche e non mediche, poi all’APHM per dirigere la ricerca a partire dal giugno 2018.

Bernard Mossé è storico, responsabile Ricerca, Educazione, Formazione dell’associazione NEEDE Méditerranée. Membro del Consiglio scientifico della Fondazione del Camp des Milles – Memoria ed Educazione per la quale è stato il responsabile scientifico e il coordinatore della Cattedra UNESCO « Educazione alla cittadinanza, scienze umane e convergenza delle memorie » (Aix-Marseille Université / Camp des Milles).