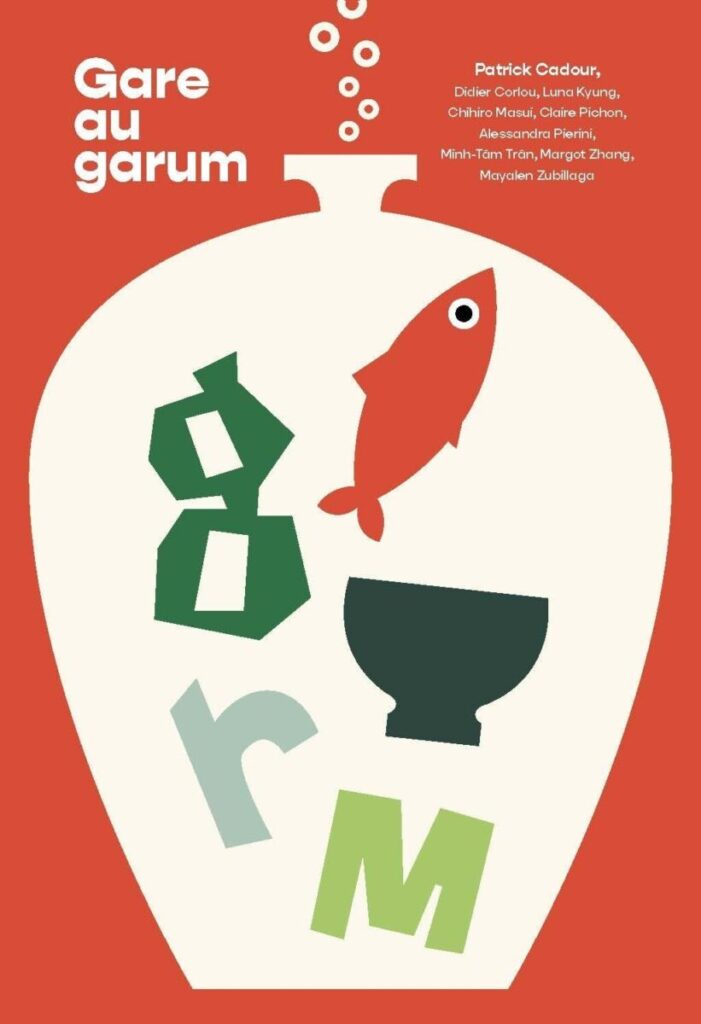È il grande ritorno del garum. Nella scia della venerabile salsa di pesce, che è stata uno dei prodotti più diffusi e consumati dell'antichità mediterranea, molti chef hanno iniziato a elaborare i propri elisir. Ma sulla Costa Azzurra, nel sud-est della Francia, gli amanti dei sapori decisi non hanno aspettato questa rinascita per godere delle virtù condimenti del loro buon vecchio garum locale.
Il garum, una fermentazione millenaria di ingredienti marini e sale, non è completamente scomparso con il declino dell'Impero romano. Anche prima di rinascere e diventare oggetto di una creatività sfrenata[1], questo condimento dai sapori intensi si perpetuava attraverso diverse specialità tradizionali, la più conosciuta è la colatura di alici, una salsa liquida e ambrata elaborata in Italia. Somiglia al nuoc-mâm vietnamita, anche se i metodi di produzione di queste due salse di pesce sono leggermente diversi[2].
Conservare le stagioni
Il garum, tuttavia, non è necessariamente liquido. Il pissalat della Costa Azzurra, un altro dei suoi discendenti, si presenta sotto forma di una pasta fluida, scura e ricca di sapore. Il suo nome deriva da pèis sala, « pesce salato ». Gli abitanti del luogo lo gustano da tempo nei loro piatti regionali, in particolare una sorta di pizza con cipolle caramellate che deve il suo nome alla pissaladière.
Per i cavalieri della confraternita del pissalat di Antibes, la filiazione con il garum, che era oggetto di una produzione industriale in tutto il Mediterraneo ai tempi dell'antica Roma, è chiara. « È per questo che, durante le cerimonie, ci vestiamo come dei Romani », spiega Louis Boyer, presidente di questa associazione creata nel 1997 per promuovere il pissalat e, soprattutto, « per divertirsi ».
Il condimento azzurro è più precisamente un hallex, halex o alec, un garum più o meno denso che, secondo Plinio il Vecchio, era inizialmente il residuo della salsa di pesce, prima di essere elaborato per se stesso con piccoli esemplari o altre specie. Il pissalat valorizza i pesci migratori che si radunano ogni anno, in primavera, vicino alle coste. Come il formaggio, che è prima di tutto un metodo di conservazione del latte, permetteva, prima dell'abbondanza alimentare, di preservare ciò che Maguelonne Toussaint-Samat chiamava la « raccolta del mare »[3], ovvero il residuo della pesca, i pesci minuscoli o le avannotti.
Alla luce dell'acqua
La lista delle specie utilizzate per confezionare il pissalat non è scolpita nella pietra. Si parla a volte di nonnat (o nonat, nounat) ma, nelle ricette tradizionali, è soprattutto la poutine a dominare. Quest'ultima designa gli avannotti traslucidi dei piccoli pesci blu, in particolare delle sardine. La sua pesca è oggi vietata, ma è oggetto di una deroga annuale dell'Unione europea per un massimo di quarantacinque giorni, alla fine dell'inverno e all'inizio della primavera, come in questo momento. Strettamente regolamentata, si pratica di giorno con la senna da spiaggia, una rete dispiegata a partire da barche e riportata a riva dai pescatori con la forza delle braccia.
Secondo l'età della sardina, si parlava un tempo di poutine « nuda » (senza squame), di poutine « vestita », di palaia o di sardineto[4]. Le seconde e le terze erano le più ricercate per il pissat, ma, in mancanza di poutine o in estate, i pescatori ricorrevano a volte alle acciughe, avannotti o adulti danneggiati dalle reti[5]. È ancora così oggi di fronte alla rarità della poutine. Flavien Falchetto, a Cros-de-Cagnes, utilizza semplicemente acciughe.

Non bisogna, però, confondere il condimento con le acciughe sotto sale, centrali nella cucina del Sud: queste ultime sono consumate sotto forma di filetti interi, anche se per ridurle in purea come nell’anchoïade. Per il pissalat, i piccoli pesci fermentano per diverse settimane con sale, chiodi di garofano e erbe, in particolare timo e alloro. Quando la pasta è pronta, viene passata al setaccio per eliminare squame, lische e aromi. A seconda della loro dimensione, i pesci possono essere eviscerati e privati della testa. Il sapore è allora più fine.
Un concentrato di umami
In cucina, il pissalat è, come le altre salse di pesce del Mediterraneo o dell'Asia, un condimento e un esaltatore di sapore. Emmanuel Pilon, chef virtuoso del ristorante Le Louis XV-Alain Ducasse a Monaco e lui stesso creatore di garums, ha utilizzato il pissalat fin dal suo arrivo in questo tempio della gastronomia mediterranea a tre stelle. Il suo obiettivo : « portare un lato salato e umami » a una partitura fortemente segnata dal vegetale.
Se ogni cavaliere della confraternita del pissalat di Antibes deve, durante la sua incoronazione, mangiare una fetta accompagnata da vino rosato, il condimento viene raramente consumato da solo. Nella pissaladière, apporta un rilievo tonico alla dolcezza delle cipolle cotte : il sapore del torna a mangiare, è lui. Le acciughe che spesso sostituiscono il pissalat, diventato raro, hanno la stessa funzione, anche se « una pissaladière senza pissalat, è una torta di cipolle parigina », dichiara Nathalie Lavitola, segretaria della confraternita e cavaliere.
Ricetta
Pissaladière al pissalat
Pelate e affettate 2 kg di cipolle gialle. Fatele dorare e cuocere in una padella con un filo d'olio d'oliva e un po' di timo, a fuoco basso e coperto. Calcolate 2-3 ore di cottura e respirate gli odori avvolgenti delle cipolle. Fuori dal fuoco, pepatele e incorporate un cucchiaio di pissalat, più o meno a seconda delle vostre preferenze.
Impastate 400 g di farina, 15 g di lievito fresco, 120 g di olio d'oliva, 150-160 ml di acqua e 1 cucchiaino raso di sale. Coprite l'impasto con un panno umido e lasciatelo lievitare per circa 1 ora. Quando è raddoppiato di volume, stendetelo in una teglia rettangolare unta e lasciatelo lievitare per un'altra ora.
Preriscaldate il forno a 200 °C. Stendete le cipolle al pissalat sulla pasta e infornate per 35-40 minuti, aggiungendo delle piccole olive nere 10 minuti prima della fine della cottura. Mangiate tiepido o a temperatura ambiente.
Il pissalat può anche essere allungato con olio d'oliva e gustato come un anchoïade, ad esempio con sedano crudo, o aromatizzare una salsa per verdure, un pan-bagnat o anche una carne alla griglia. Più a ovest, intorno allo stagno di Berre, un garum simile e ancora più riservato suona quasi la stessa musica, ma questa è un'altra storia.
[1] René Redzepi e David Zilber, Il Guida alla fermentazione del Noma, Le Chêne, 2018.
[2] Vedi il volume collettivo Gare au garum pubblicato nel 2024 dalle Éditions de l’Épure, un giro del mondo delle salse di pesce in racconti e ricette.
[3] Maguelonne Toussaint-Samat, La Cucina rustica. Provenza, Robert Morel, 1970.
[4] Apollon Caillat, 150 modi di cucinare le sardine, 1898.
[5] Garum e Pissalat. Dalla pesca alla tavola. Memorie di una tradizione, catalogo della mostra del museo di Archeologia di Antibes, Antibes, Editions Snoeck/Direzione della città di Antibes, 2007.
Mayalen Zubillaga, autrice culinaria, è cresciuta sulle rive dello stagno di Berre circondata da fave, mugini e effluvi petrolchimici. Caduta in una pentola di polpette quando era piccola, cucina e scrive a tutto campo, esplorando sia il pan-bagnat, le acciughe sotto sale e la magia ecumenica del ceci.