A lungo considerata come una zona di transito o di partenza, il Mediterraneo è oggi al centro delle dinamiche migratorie globali. Tra trasformazioni economiche, politiche, simboliche e sociali, le migrazioni si complicano, alimentando tensioni e fantasmi. Il sociologo Andrea Calabretta illumina queste questioni attraverso le sue ricerche sui percorsi migratori in Italia e oltre.
Questo articolo è un riassunto di 4 interviste tra scienziati pubblicate in 22-med nell'ottobre 2024. Un dialogo tra Bernard Mossé, responsabile scientifico di Neede Mediterraneo, e Andrea CALABRETTA ricercatore all'università di Padova (Italia), dove tiene corsi sulle metodologie di ricerca qualitativa in sociologia. Oltre alle relazioni con il contesto di origine, ha lavorato sui processi di inclusione ed esclusione sociale che colpiscono i migranti e i loro discendenti. Le 4 interviste sono disponibili QUI nelle 11 lingue utilizzate sul sito.
Le migrazioni non sono una novità. « Il mondo in cui viviamo è stato costruito dalle migrazioni », ricorda Andrea Calabretta. L'Italia è un esempio lampante: tra il 1876 e il 1988, quasi 27 milioni di italiani sono emigrati. Oggi, il Mediterraneo diventa una regione di accoglienza, di transito, ma anche di ricomposizione identitaria. Dagli anni '90, la caduta del blocco sovietico, l'aumento dei trasporti e delle reti digitali hanno trasformato le mobilità umane: i flussi migratori non seguono più i modelli antichi. Si globalizzano, si femminilizzano, si frammentano.
Categorie da ripensare, confini da comprendere
Di fronte alla diversità dei percorsi, le categorie amministrative classiche — rifugiato, migrante economico, ricongiungimento familiare — diventano inadeguate. « I sociologi devono evitare di riprodurre i quadri dello Stato », sottolinea Calabretta, che sostiene una lettura critica delle nozioni imposte dalle politiche migratorie. L'emergere degli « studi sui confini » illustra questa evoluzione: il confine diventa un filtro selettivo, più che un muro, creando stati precari a geometria variabile all'interno delle stesse società di accoglienza. Risultato: una « piramide della cittadinanza » in cui i diritti sono distribuiti in modo diseguale.
Il Mediterraneo, laboratorio delle tensioni migratorie
Nel Mediterraneo, le migrazioni sono fortemente politicizzate. Dagli anni '90, le condizioni di ingresso in Europa si sono inasprite, trasformando il mare in un confine mortale. Secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, più di 30.000 persone sono morte in dieci anni nel tentativo di attraversarlo. Questa chiusura alimenta un discorso di paura, spesso in disaccordo con la realtà. Le migrazioni Sud-Sud, più numerose di quelle verso il Nord, sono poco mediatizzate. Lontano da un'invasione, le mobilità attuali sono complesse, motivate da ragioni intrecciate: economiche, familiari, climatiche, personali.
L'esclusione si costruisce anche dall'interno
L'esperienza della comunità tunisina a Modena mostra come le distinzioni tra « vecchi » e « nuovi » migranti si cristallizzino. In tempi di crisi, i gruppi dominanti rafforzano le gerarchie, e i migranti già stabiliti possono cercare di differenziarsi dai nuovi arrivati. Questa logica di frammentazione è rafforzata da politiche pubbliche che sfruttano le divisioni interne. « Anche se ben integrati, i discendenti di migranti possono continuare a essere percepiti come stranieri », osserva Calabretta. La questione è quindi riconoscere la costruzione sociale di queste categorie, e non essenzializzarle.
Verso una ricomposizione sociale lenta ma necessaria
Le migrazioni nel Mediterraneo rivelano tensioni, ma anche opportunità di ricomposizione sociale. « Il cambiamento arriverà lentamente, con conflitti, ma è inevitabile », afferma Calabretta. Il riconoscimento della pluralità dei percorsi, l'integrazione dei discendenti, e una rilettura delle politiche migratorie attraverso il prisma delle realtà vissute sono le condizioni per una società più inclusiva. Comprendere questa complessità è un prerequisito essenziale per qualsiasi azione pubblica sostenibile.
Biografie

Andrea CALABRETTA è ricercatore postdoc all'università di Padova (Italia), dove tiene corsi sulle metodologie di ricerca qualitativa in sociologia. Ha conseguito il dottorato nel 2023 con una tesi sulle relazioni transnazionali tra la comunità tunisina in Italia e il paese d'origine, basata sulla mobilitazione delle teorie di Pierre Bourdieu. Oltre alle relazioni con il contesto di origine, ha lavorato sui processi di inclusione ed esclusione sociale che colpiscono i migranti e i loro discendenti, i loro percorsi di lavoro nella società italiana e i processi di costruzione identitaria dei migranti.

Bernard Mossé è storico, responsabile Ricerca, Educazione, Formazione dell'associazione NEEDE Mediterraneo. Membro del Consiglio scientifico della Fondazione del Campo dei Mille – Memoria ed Educazione per la quale è stato responsabile scientifico e coordinatore della Cattedra UNESCO « Educazione alla cittadinanza, scienze umane e convergenza delle memorie » (Aix-Marseille Université / Campo dei Mille).
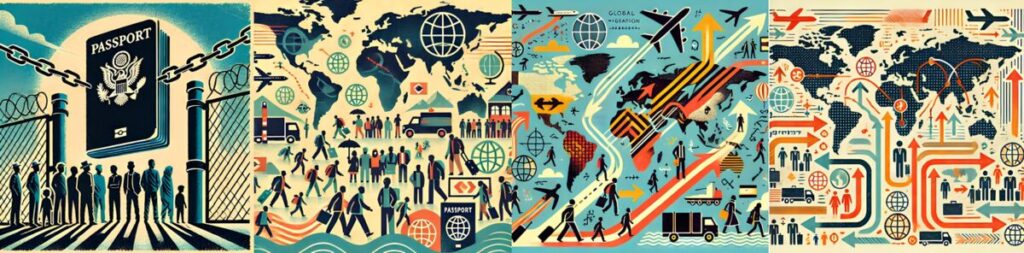
Foto di copertura: Barche di migranti nel porto di Lampedusa © Dionigi Albera
Indicizzazione: Biblioteca delle conoscenze mediterranee
Migrazioni nel Mediterraneo
Andrea Calabretta – Bernard Mossé
22-med
14 agosto 2025
• La migrazione è un fenomeno storico permanente nel Mediterraneo che si complica dagli anni '90.
• Il Mediterraneo è un laboratorio delle tensioni migratorie: politicizzazione, confini, morti in mare, criminalizzazione.
• Le categorie amministrative sono inadeguate alla realtà vissuta dei percorsi.
• La migrazione non è mai monocausale: coniuga ragioni economiche, climatiche, sociali e personali.
• I migranti sono sia attori che vittime delle gerarchie sociali, anche all'interno della loro comunità.
• L'evoluzione passa attraverso una ricomposizione sociale lenta ma necessaria.
Tunisia – Italia
#migrazione #Mediterraneo #confine #politicizzazione #Tunisia #Italia #sociologia #gerarchia_sociale #complessità #globalizzazione #secondarietà
