Il Mediterraneo è uno spazio rappresentativo delle migrazioni nel mondo. Questo argomento, mediatico e politicizzato, è oggetto di semplificazioni e luoghi comuni proprio nel momento in cui, da circa trent'anni, diventa sempre più complesso e diversificato.
È al centro di questo dialogo tra Bernard Mossé, responsabile scientifico di NEEDE Méditerranée, e Andrea Calabretta, sociologo esperto di migrazioni nel mondo, nel Mediterraneo e in Italia in particolare. Per capire meglio questa complessa problematica.
Da seguire per cinque settimane.
# 3 - Il Mediterraneo è caratteristico della politicizzazione del tema della migrazione
Bernard Mossé: Hai delineato un panorama delle migrazioni nel mondo e della sociologia delle migrazioni negli ultimi decenni. Puoi concentrarti sul fenomeno migratorio nel Mediterraneo?
Andrea Calabretta: Sì, certo. Il rischio con il Mediterraneo è pensarlo come centro del mondo. Ma credo davvero che il Mediterraneo sia uno degli spazi paradigmatici della migrazione. È uno spazio che ci permette di comprendere le nuove dinamiche, rimodellando le dinamiche del passato. E riguardo a ciò, penso che oggi si possano distinguere quattro aspetti, quattro dimensioni.
La prima, l'ho già affrontata, è il tema della politicizzazione. È veramente al centro della questione migratoria oggi, e lo vediamo molto bene nel Mediterraneo.
Prendiamo il caso italiano. Fino agli anni '90, si poteva arrivare in Italia senza un sistema di visto. Davvero, si poteva partire da qualsiasi parte del mondo e, con un passaporto, arrivare a Roma o Milano... Era davvero la libera circolazione, ed è una cosa così lontana oggi che bisogna sforzarsi per immaginarla... è incredibile: non abbiamo più gli strumenti nemmeno per concepirla ed è in uno spazio di 30 anni che la realtà è completamente cambiata.
Se prendiamo i dati dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), si contano 30.000 persone che sono morte negli ultimi 10 anni attraversando il Mediterraneo, di cui l'80% nel Mediterraneo centrale, cioè per raggiungere l'Italia. Si parla di migliaia e migliaia di persone che sono morte per attraversare un confine che, fino agli anni '90, non esisteva.
Si può vedere molto bene nel Mediterraneo come la politicizzazione del tema, la sua criminalizzazione, abbia effetti tragici e multidimensionali. Partendo dal presupposto che ci sono popolazioni in movimento, prive di risorse, facili da emarginare, estranee al di fuori del nostro gruppo. E questa vulnerabilità ci permette di costruire un'identità sociale a basso costo.
Questa è la prima dimensione mediterranea, paradigmatica di ciò che accade nel mondo.
Una seconda dimensione, legata a questa prima, è quella delle frontiere. La visibilità data alle migrazioni ha accentuato il peso della questione delle frontiere. Non solo nel senso comune, ma anche tra gli studiosi, con lo sviluppo degli Border Studies, che non esistevano 30 o 40 anni fa. I lavori di Sandro Mezzadra, per esempio, ci dicono che si può utilizzare la frontiera come strumento epistemologico per comprendere la migrazione e la società in generale. È il caso del confine messicano o altrove. Ma il Mediterraneo è centrale nella costruzione della frontiera come oggetto normativo, oggetto politico e anche oggetto scientifico.
Si parla della "fortezza Europa". Ma la frontiera dovrebbe essere vista meno come un muro e più come un filtro che trattiene alcuni e lascia passare altri. E che rimane sulle spalle delle persone che la attraversano. Si osserva così la moltiplicazione delle frontiere interne nelle società europee del nord del Mediterraneo. Si sta creando una società frammentata con una piramide della cittadinanza: ci sono cittadini sulla carta, ma non riconosciuti come tali; persone di lungo soggiorno, breve soggiorno, richiedenti asilo... Questi diversi status sono funzionali per le nostre economie. Se pensiamo ai migranti lavoratori degli anni '90, o persino del 1970, arrivavano con uno status molto preciso, mentre oggi ad esempio i richiedenti asilo sono spinti a lavorare per dimostrare di meritare l'asilo. Come se ci fosse un sospetto a priori su questo... È una situazione ovviamente molto più precaria di un tempo...
Bernard: Su questo punto, possiamo dire che esiste un confine sociale poroso tra l'immigrato e il rifugiato, e persino una confusione politicamente mantenuta tra il migrante e l'esule?
Andrea: Direi che non si tratta di una confusione "naturale" nel senso che si basa sul bisogno di manodopera straniera: si ha così uno status più precario, più sfruttabile, ad esempio per l'agricoltura nel sud dell'Italia. Questa moltiplicazione delle frontiere esterne e interne nel Mediterraneo rende più complessa la vita delle persone...
Questo era la seconda dimensione. Il terzo punto ci riporta a domande già affrontate: la complessificazione delle motivazioni degli attori in movimento.
Siamo passati da un quadro di accordi internazionali molto precisi, negli anni '50, per l'invio di manodopera dalla sponda sud alla sponda nord, tra i paesi del Maghreb e la Francia, tra l'Italia e il Belgio, tra la Turchia e la Germania...
Avevamo anche un'altra categoria molto specifica, quella del regroupement familial.
Ma oggi, le motivazioni sono molteplici e interconnesse, e le categorie dello Stato sono inadeguate: i richiedenti sono persone che vengono a lavorare, ma anche che si spostano per questioni di salute, familiari...
Si potrebbe anche porre la domanda sulla crisi climatica come motivazione della migrazione. È essa una motivazione tra le altre o è prioritaria, nel mondo e nel Mediterraneo in particolare?
C'è un discorso catastrofico da parte delle organizzazioni internazionali su questo argomento. Penso, naturalmente, che stiamo vivendo una crisi climatica molto profonda, ma il legame che queste organizzazioni fanno tra la crisi climatica e la migrazione mi sembra politicizzato ed esagerato.
Riprendo l'analisi del sociologo olandese, Hein de Haas. Ad esempio, l'OIM ci dice che nel corso del decennio 2012-2022, più di 21 milioni di persone hanno migrato a causa di catastrofi naturali. E la stessa organizzazione ci dice che entro il 2050, ci saranno 1 miliardo di persone esposte al rischio climatico nelle zone costiere. Si tratta di una visione piuttosto meccanica della migrazione. La migrazione non è mai monocausale. I migranti non sono oggetti che si spostano meccanicamente nel mondo. Senza contare due fenomeni ricorrenti noti:
- Innanzitutto, il fenomeno della resilienza: le popolazioni tendono molto spesso a rimanere nel luogo in cui sono cresciute e ad adattarsi ai cambiamenti delle condizioni ambientali.
- D'altra parte, non sono i più svantaggiati a migrare. Non sono né i più poveri né i più ricchi, ma sono persone della classe media che cercano di migliorare le proprie condizioni.
Se si utilizzano i numeri e le proporzioni forniti dalle organizzazioni internazionali, per proiezioni molto distanti nel tempo, non si prevede una realtà oggettiva, ma si pone un problema da gestire. Si ritrova sempre questa questione della politicizzazione.
Ci saranno ovviamente aree fortemente colpite dal cambiamento climatico che potrebbero generare movimenti migratori, combinati alla ricerca di una vita economica migliore o di esperienze biografiche, ma non si può pensare alla crisi climatica come a un gioco di bocce che spinge le palline. È un tema da affrontare, sì, ma non come una paura.
Bernard: Nel senso comune, come dici, c'è anche l'idea dell'invasione. Non è smentita dal fatto che le migrazioni Sud-Sud stiano diventando maggioritarie e dall'importanza delle migrazioni di prossimità?
Andrea: Sì, ci sono molte idee preconcette da sfatare, anche nel discorso sociologico. Riguardo alle migrazioni Sud-Sud, ho individuato dati molto interessanti dall'OIM. Si pensa ancora che i paesi poveri siano paesi di emigrazione. Ma tra i paesi con il maggior numero di emigranti al mondo, troviamo il Regno Unito e la Germania al 14° e 18° posto. Al contrario, la Cina, che viene considerata un paese povero, accoglie un gran numero di migranti. È un mondo molto più complesso di quanto i discorsi lascino intendere. Ci sono spostamenti brevi, migrazioni Sud-Sud, movimenti secondari sempre più complessi. E la crisi climatica che rende il quadro ancora più complesso... Questo è il nostro mondo... è complesso, ma la retorica allarmista dell'invasione non corrisponde alla realtà.
Terminerei, se lo desideri, con la quarta dimensione delle migrazioni mediterranee. Si tratta della complessificazione non solo delle categorie di attori e delle motivazioni, ma anche dei contesti. Si può pensare al caso dell'Italia, che fino all'inizio del XX secolo era un paese di emigrazione e, a partire dagli anni '70, pur continuando ad essere un punto di partenza per le emigrazioni verso la Francia e l'Europa del Nord, diventa anche una destinazione per le migrazioni internazionali. Negli ultimi anni ha anche sperimentato la realtà delle migrazioni interne diventando sempre più un paese di transito. E questo vale per tutta la regione del Mediterraneo, in Spagna, Grecia o Portogallo, ma anche in Turchia o in Tunisia.
Questa complessificazione è anche legata, come abbiamo visto, a una complessificazione interna delle gerarchie sociali, con stati giuridici e sociali diversi, ma anche a causa di una complessificazione a livello internazionale, poiché c'è la necessità di negoziare con i paesi della sponda sud che sono interconnessi dai movimenti migratori.
Biografie

Andrea CALABRETTA è un ricercatore postdoc presso l'Università di Padova (Italia), dove tiene corsi sulle metodologie di ricerca qualitativa in sociologia. Ha conseguito il dottorato nel 2023 con una tesi sulle relazioni transnazionali tra la comunità tunisina in Italia e il paese d'origine, basata sull'applicazione delle teorie di Pierre Bourdieu. Oltre alle relazioni con il contesto di origine, ha lavorato sui processi di inclusione ed esclusione sociale che influenzano i migranti e i loro discendenti, i loro percorsi lavorativi nella società italiana e i processi di costruzione dell'identità dei migranti.
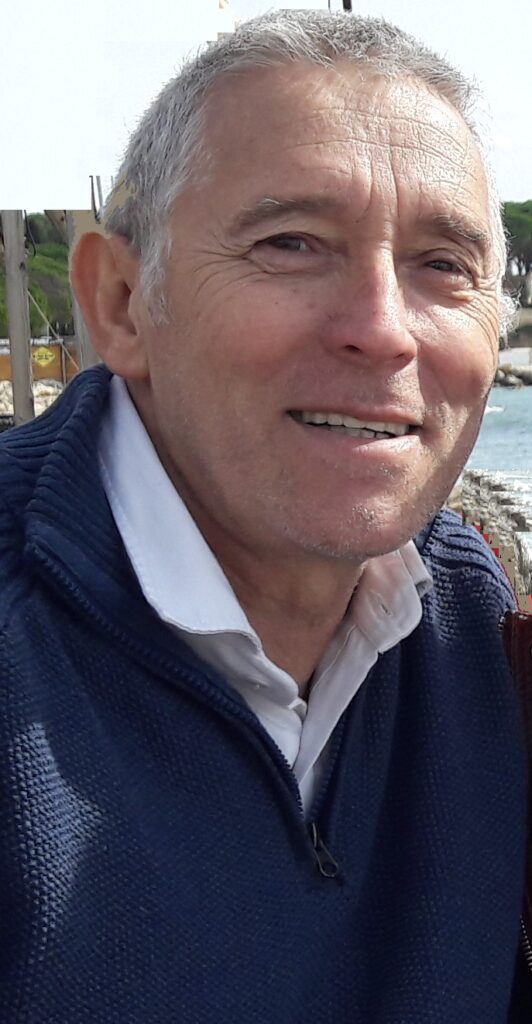
Bernard Mossé Storico, responsabile della Ricerca, dell'Educazione, della Formazione dell'associazione NEEDE Mediterraneo. Membro del Consiglio scientifico della Fondazione del Campo dei Mille - Memoria ed Educazione, per la quale è stato responsabile scientifico e coordinatore della Cattedra UNESCO "Educazione alla cittadinanza, scienze umane e convergenza delle memorie" (Università di Aix-Marseille / Campo dei Mille).
Bibliografia Appadurai Arjun (2001), Dopo il colonialismo. Le conseguenze culturali della globalizzazione, Parigi: Payot.
Bourdieu Pierre, Wacquant Loïc (1992), Réponses. Pour une anthropologie réflexive. Parigi: Seuil.
Calabretta Andrea (2023), Accettare e combattere la stigmatizzazione. La difficile costruzione dell'identità sociale della comunità tunisina a Modena (Italia), Territori contemporanei, 19. http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/publications/Espaces-Territoires/Andrea_Calabretta.html
Calabretta Andrea (2024), Doubles absences, doubles présences. Le capital social comme clé de lecture de la transnationalité, In A. Calabretta (ed.), Mobilités et migrations trans-méditerranéennes. Un dialogue italo-français sur les mouvements dans et au-delà de la Méditerranée (p. 137-150). Padova: Padova University Press. https://www.padovauniversitypress.it/system/files/download-count/attachments/2024-03/9788869383960.pdf
Castelli Stephen, De Haas Hein e Miller Mark J. (2005 [ultima edizione 2020]), *The age of migration. International Population Movements in the Modern World, New York: Guilford Press.
de Haas Hein (2024), “L’idée di grandi onde di migrazioni climatiche è molto improbabile”, articolo su ‘L’Express’.
Elias Norbert (1987), Il Ritiro dei Sociologi nel Presente, Theory, Culture & Society, 4(2-3), 223-247. https://journals.sagepub.com/doi/epdf/10.1177/026327687004002003
Elias Norbert, Scotson John L. (1965 [riedizione 1994]), Gli stabili e gli outsiders. Un'indagine sociologica sui problemi della comunità. Londra: Sage.
Fukuyama Francis (1989), "La fine della storia?" The National Interest, 16, 3-18. https://www.jstor.org/stable/24027184
Mezzadra Sandro, Neilson Brett (2013), Border as Method, Durham: Duke University Press. https://academic.oup.com/migration/article-abstract/4/2/273/2413380?login=false
Sayad Abdelmalek (1999a), La double absence. Dalle illusioni dell'emigrato alle sofferenze dell'immigrato. Parigi: Editions du Seuil.
Sayad Abdelmalek (1999b), Immigrazione e "pensée d'État". Actes de la recherche en sciences sociales, 129, 5-14.
https://www.persee.fr/doc/arss_0335-5322_1999_num_129_1_3299 Simmel Georg (1908 [riedizione 2019]), L'étranger, Paris

Da questa conversazione, l'IA ha generato un flusso di illustrazioni. Stefan Muntaner l'ha alimentata con i dati editoriali e ha guidato la dimensione estetica. Ogni illustrazione diventa così un'opera d'arte unica tramite un NFT.
