Edmond Amran El Maleh, colui che viene soprannominato "il Joyce marocchino" ci ha lasciati quasi quindici anni fa. Simone Bitton, che si riconosce nella sua radicalità etica ed estetica, di fronte al sionismo e per un'arte allegorica, senza compromessi, gli dedica un film documentario, tutto in giustezza e forza evocativa, I mille e un giorni del Hajj Edmond. Qui ritrae uno scrittore plurale e un essere sia singolare, intransigente e accogliente.
In cesellatrice di parole e immagini, Simone Bitton ha scelto, nel film documentario che ha dedicato allo scrittore Edmond Amran El Maleh (1917-2010), di adottare un tono epistolare alla seconda persona riprendendo l'attributo culturale che gli davano i suoi amici a Rabat, Asilah, Parigi, Essaouira o Beni Mellal, di Hajj. Questo soprannome misto, spostato, di Hajj Edmond, che fa il titolo del film, gli toglieva ogni sospetto di estraneità rispetto a una nazione sincretica, intrecciata di islamità, di ebraicità e altre forme di spiritualità popolari, e sottolineava la sua figura di uomo affabile, rispettato. In una delle sue professioni di fede registrate nella rivista Les temps modernes, si era definito "marocchino ebreo" (non-ebraico marocchino), insistendo sulla preminenza della sua terra sulla sua obbedienza. Così designava il suo passo laterale identitario, il suo rapporto fusionale con la sua comunità di destino, il suo modo di intrecciare i diversi fili che lo legavano con delicatezza alla sua località e, di conseguenza, il suo desiderio di umanesimo decentrato.
Marocchino ebreo
I mille e un giorni del Hajj Edmond. Sono condensati nell'enunciato del film, il dramma originario di esodo orchestrato sin dalla metà degli anni '50, da un giorno all'altro dall'Agenzia ebraica con la complicità delle autorità marocchine, di popolazioni ebraico-amazigh, sedentarie da oltre duemila anni, e l'evocazione malinconica, allegorica, che ne fa l'autore in Parcours immobile (Maspero, 1980), poi Mille anni un giorno (Pensée sauvage, 1986). La tomba di Nahon, designato come l'ultimo ebreo sepolto ad Asilah, l'autore se ne appropria, mentre pubblica il suo primo romanzo a sessantatre anni, per dire "la morte emblematica di una comunità e il suo radicamento in questa terra". Non è solo per la Palestina depredato che questo scrittore, radicalmente opposto alla politica coloniale israeliana, ce l'ha con il sionismo, ma molto più fondamentalmente per aver impoverito, privato il suo Marocco natale, come altre nazioni arabe, della sua pluralità millenaria.
Quando Simone Bitton, ancora giovane, apprendista cineasta, fuggita da Israele alla fine degli anni '70, lo incontrava a Parigi, dove si era esiliato dal 1965, lui la interrogava a lungo sulle condizioni di vita degli sefarditi là. Il suo sogno segreto, utopico, era che si sentissero a disagio e decidessero di tornare nel loro vero paese, il Marocco. A sua insaputa, si è trasformata più tardi in personaggio investigatore nei suoi testi letterari. E lui ha popolato i suoi romanzi, in una linfa joyciana, di risonanze, di profumi, di sonorità, di parole vernacolari, che dicono tanto la malinconia della perdita quanto la poetica dell'attaccamento.
Una vita feconda
Come Marcel Proust, è stato a lungo, giovane a Safi poi a Casablanca, durante gli anni '20 e '30, atrocemente asmatico, esile, confinato nella casa familiare. Quando prende la penna per scrivere il suo dolore esistenziale decenni dopo, evoca "la nascita di un giovane saggio che sognava di diventare un allevatore di parole".
Le sue frasi non cercano di testimoniare il mondo, ma di crearne uno, ricettacolo di frammenti di vite irriducibili a un'autobiografia. Sensibile al suo universo fecondo, Simone Bitton ha arricchito il suo film di piani sequenza che raccontano frammenti della sua vita e di piani fissi che invitano, come in un rizoma, a percorrere le innumerevoli arterie che disegnano i suoi scritti. E poiché l'urgenza che percepiva era tanto etica quanto estetica, ha ben ridisegnato la sua traiettoria singolare, dalla resistenza e dal comunismo, che si dimostra faticoso per lo stalinismo, ma insuperabile per i suoi valori, ai laboratori di artisti pittori inclassificabili (Ahmed Cherkaoui, Khalil Ghrib, Hassan Bourkia ...) che ha amato perché attenti all'effimero e all'insuperabile.
Da un capo all'altro, ricostruisce un'abbondanza d'amore, prima per la sua compagna, Marie Cécile Dufour, conosciuta inizialmente a Casablanca, dove entrambi insegnavano filosofia, prima dell'esilio. Lei gli è stata a lungo quasi un metronomo della sua vita. Specialista di Walter Benjamin, il suo sosia, diceva, quasi per scherzo, che facevano con lui ménage à trois. Poco loquace in parole, vegliava con una ferma benevolenza sulla coerenza del suo universo, sulla forza dei suoi testi e sul loro diritto all'opacità, a portarlo con sé al mulino dei suoi genitori in Borgogna, e ripartire con lui in auto, regolarmente, dieci anni dopo l'esilio, ogni estate, nel suo amato Marocco.
Da loro, un piccolo appartamento al 114 Bd Montparnasse a Parigi, per oltre trenta anni, lei aveva il suo telaio e lui il suo armadio che gli serviva da cucina per preparare i suoi piatti speziati, e intorno a loro un interminabile balletto di amici, dove si incrociavano il Marocco, la Palestina, il Libano, la filosofia, i dibattiti politici, le risate schiette e la sensazione di essere sempre accolti da una coppia amorevole in cerca di figli. Da loro, si ritrovavano senza formalità esseri sensibili alle repressioni e ai drammi del mondo e ne discutevano spesso con una radicale umanità.
Nel film, Mohamed Tozy, Dominique Eddé, Leila Shahid, Réda Benjelloun e Abderrahim Yamou raccontano o leggono a turno episodi di questa vita buona, le sfumature di una coscienza politica maltrattata, ma allo stesso tempo gli echi di una voce letteraria significativa. Hajj Edmond non ha mai ceduto alle sirene dei salotti parigini né ai lampadari di una francofonia ingannevole. Il suo attaccamento, oltre alla sua terra, è alla sua lingua madre, alla rudezza dei suoni che attraversano il testo scritto per dargli una linfa e una densità memoriale. E una volta tornato al suo nido, dopo la partenza di Marie Cécile, incoraggiato dal suo amico scrittore Mohamed Berrada, ci sarà un altro cenacolo nella sua nuova dimora ad Agdal, Rabat, dall'anno 1999 fino alla sua partenza.
Figura di Hajj Edmond
L'appellativo Hajj Edmond assume allora tutto il suo significato, perché così lo chiamano le persone comuni a casa sua. Ma al di là dell'atto di deferenza, questo sigilla la forza di un'amicizia profonda con persone di ogni estrazione, che lo adottano come uno dei loro. L'kbira, la donna che si prendeva cura di lui e di cui lodava la gastronomia, lo dice spontaneamente nel film: "era un ebreo musulmano". Nel mausoleo, simbolicamente eretto alla sua effigie al Maqam, questo sincretismo, che sottolinea il suo attaccamento a una spiritualità mista, ancestrale, è tradotto spazialmente. Così come, il giorno dopo la sua morte, il 15 novembre 2010, la sua sepoltura nel cimitero ebraico di Essaouira, riaperto per l'occasione, rimanda simbolicamente a quella di Asilah dove ha collocato fictionariamente Nahon, l'ultimo ebreo sepolto.
Le riprese del documentario erano praticamente terminate prima del 7 ottobre 2023, ma il suo montaggio è stato effettuato per tutto il periodo genocida insostenibile. Simone Bitton dice di aver tenuto duro perché, di fronte al disastro, questo era un debito. Edmond Amran El Maleh ha fatto parte di quei rari ebrei arabi, inconsolabili per il rapimento politico avvenuto in Marocco, come in Algeria, in Tunisia o in Iraq, sulle macerie del nazismo, come era senza compromessi sul diritto dei palestinesi al loro Stato e al ritorno legittimo. Non lo era come un militante politico o un produttore di discorsi convenzionali, ma piuttosto come un tessitore di racconti, un evocatore di memorie e un insaziabile allevatore di parole giuste.
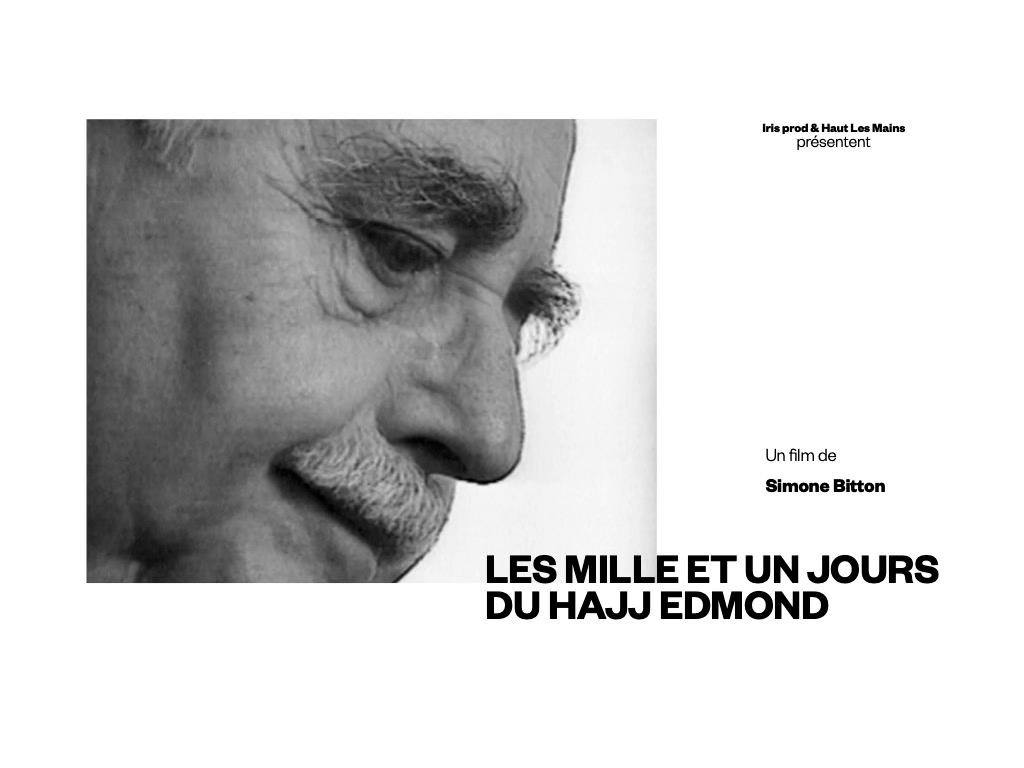
Driss Ksikes è scrittore, autore teatrale, ricercatore in media e cultura e preside associato alla ricerca e all'innovazione accademica a HEM (università privata in Marocco).
