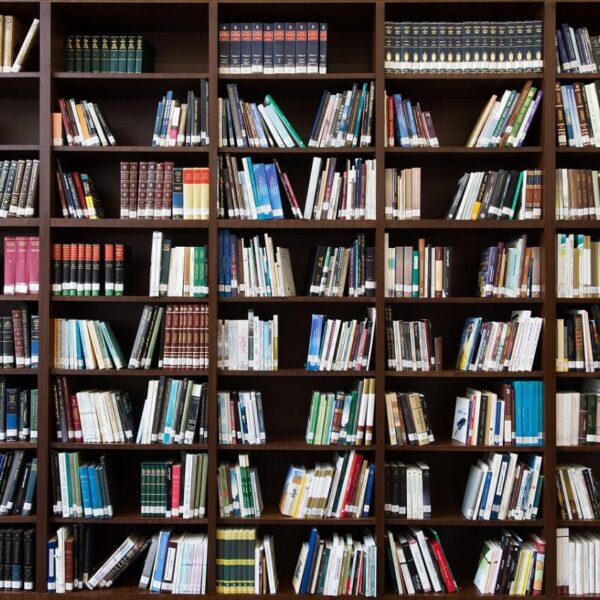Nel momento in cui, all'ONU, un'iniziativa franco-saudita mette all'ordine del giorno internazionale il riconoscimento dello Stato di Palestina, si rivela che lampi di lucidità, ancor prima di quelli dei politici, possono sorgere dalla poesia e dalla letteratura. Cosa ci dicono tre opere recenti firmate da autori marocchini che affrontano la Palestina in modo diverso?
Indice IA: Biblioteca delle conoscenze mediterranee
Cosa può la letteratura quando la Palestina non può?
22-med – settembre 2025
• Di fronte all'impotenza politica, la letteratura diventa un'arma fragile ma vitale per la Palestina.
• Tre autori marocchini fanno risuonare, ciascuno a modo loro, le voci soffocate di Gaza.
#palestina #letteratura #poesia #memoria #mediterraneo
"A cosa servono i poeti in tempi di crisi?". Citando il poeta tedesco Friederich Hölderlin, il giorno dopo la Seconda Guerra Mondiale, Patrick Chamoiseau afferma di scrivere il suo ultimo saggio Cosa può la letteratura quando non può? (Seuil Libelle, 2025), per interrogare la sua utilità o, più esattamente, per affermare la sua necessaria inutilità. In un testo scritto in frammenti sensibili (una sentimentoteca), l'autore martiniquese si riferisce, partendo dall'Olocausto, a Théodor Adorno, che a sua volta affermava che era "impossibile fare come se nulla stesse accadendo".
Nella sua passeggiata storico-letteraria, che va da Faulkner a Glissant, da Kafka a Gabriela Marquez, senza dimenticare le innumerevoli favole e poesie fondamentali di popolazioni dimenticate, cerca di significarci, in eco alle atrocità attuali, in Medio Oriente e altrove, l'urgenza di afferrare di cosa la letteratura potrebbe salvarci. Né dalla morte né dall'orrore, questo è scontato. Ma dall'illusione di un universale totalizzante, dal grande racconto occidentalo-centrato. Inoltre, sottolinea la nostra incapacità di afferrare l'incredibile diversità delle "catture poetiche" e "organismi narrativi" che aiutano a rattoppare, attraverso legami inaspettati, il "tutto-mondo".
Di fronte all'impotenza palestinese
Ristretto il campo sulla Palestina. Due anni dopo l'attacco traumatico ai civili israeliani, c'è sempre più unanimità sul fatto che la risposta che ha causato la distruzione quasi totale della striscia di Gaza, la morte di decine di migliaia di palestinesi e la fame di una popolazione assediata sia stata non solo eccessiva, ma criminosa. Nel contempo, questa tragedia è rivelatrice della sconfitta inaspettata dei valori universali, tanto è terrificante il diniego e l'impotenza di fronte all'innominabile.
Cosa può, dunque, la letteratura di fronte a tutto ciò, all'annegamento di vite bombardate al ritmo di rifornimenti di armi all'infinito, alla disumanizzazione e animalizzazione di abitanti senza uscita, come preludio alla loro sterminazione o deportazione desiderata? Tre pubblicazioni di autori marocchini mi sono sembrate tentare, ciascuna a modo suo, di dire modestamente, in eco a Chamoiseau, "ora che vediamo, sappiamo, leggiamo, che siamo tutti responsabili delle nostre azioni e inazioni, diciamo, sì, la letteratura può fare qualcosa". Può, invece di venderci ancora lo stesso falso discorso universalizzante, aiutarci a vedere con quale grazia gli esseri umani possono "diversalizzare" e di conseguenza esprimere la loro anima irriducibile a partire dai loro luoghi di vita e dai loro infimi percorsi di speranza.
Laâbi e le ventisei voci di Gaza
In L'Antologia della poesia gazaouie di oggi (Points, 2025), i ventisei testi riuniti dall'autore marocchino Yassin Adnan e tradotti da Abdellatif Laâbi, ci vengono presentati come tanti echi sorprendenti dell'intuizione di Aimé Césaire, che "i poemi servono come armi miracolose capaci di uccidere il virus dell'odio e minare il culto della forza". Nella sua introduzione, Laâbi cita questi versi del giovane poeta palestinese, Marwan Maaqoul, diventati emblematici, ampiamente ripresi sui social media:

Per scrivere una poesia
che non sia politica
devo ascoltare gli uccelli
E per ascoltare gli uccelli
deve cessare il rumore del bombardiere.
Rifiutando ogni forma di analisi che definisce "pseudo-scientifica", Laâbi si applica e applica ai lettori di questi poeti sconosciuti, invisibili, parlando dall'interno, a partire da una matrice bruciata, l'invito seguente che ci impongono: "Tacete. Lasciateci parlare". Il poeta marocchino ci invita così a leggerli nella loro incredibile fragilità e incommensurabile potenza. Dietro la sua volontà di lasciare che le loro voci emergano come tante emanazioni umane disperate, ci offre di vedere diversamente questo luogo "abbandonato dagli dèi e dagli uomini" e le loro poesie come l'ultima forma di resistenza contro la morte. Attraverso la bellezza e la forza delle loro parole, dimostrano la correttezza di quest'idea che gli sta molto a cuore: "un popolo non può trionfare sul suo oppressore se non gli è superiore, moralmente".
Benzine e la storia di un contro-reportage

Lo scrittore franco-marocchino, Rachid Benzine, passato dall'islamologia alla narrativa per raccontare diversamente questo altro continente umano (i musulmani) che l'Occidente guarda spesso dall'alto in basso, è diventato in pochi anni un sostenitore di testi brevi, incentrati su un fenomeno o un personaggio, per tradurre senza giri di parole le lacune di rappresentazione da colmare. Nel suo ultimo romanzo, che assomiglia più a una novella, L'uomo che leggeva libri (Julliard, 2025), Julien Desmanges, giovane fotografo partito in reportage a Gaza prima del 2014, per catturare la foto che avrebbe colpito, si aggira tra le viuzze, i detriti, il caos circostante, e finisce per imbattersi accanto al caffè di Hafez, in un vecchio libraio, Nabil El-Jaber, dal francese perfetto e dalla pazienza disarmante.
Attraverso questo espediente narrativo, dove invece di scattare una foto, il reporter diventa il destinatario di un racconto inaspettato, l'autore trova il modo indiretto di raccontare, attraverso il percorso personale e familiare di un solo uomo, la Palestina dal 1948, l'esilio, la prigione, Haifa, l'OLP, l'apartheid, l'UNRWA, gli studi in Egitto, la prigione in Israele, ma anche i libri accumulati intorno, decifrati nel corso di uno sguardo: Hugo, Amleto, Darwich, Genet e molti altri. L'epilogo del libro ci informa che, tornato undici anni dopo, in una Gaza devastata, il libraio, come tutte le tracce dei luoghi che aveva conosciuto, visitato, o di cui aveva preso tempo per apprezzare, era introvabile. Come se Benzine cercasse, attraverso questo ricordo, ricostruito con una certa sensibilità, di fare l'inventario di ciò che il disastro non potrebbe cancellare, l'amore per i libri popolati di vite. Questo racconto parabolico è stato ricevuto, nel silenzio assordante degli scrittori francofoni, come un incredibile richiamo alla realtà.
I sogni tenaci di Kébir Mustapha Ammi

Di fronte al desiderio di dare voce ai subalterni o di aggirare la possibilità di far emergere un racconto dalle macerie, lo scrittore maroco-algerino, Kébir Mustapha Ammi, sceglie per esprimere a modo suo il malessere di fronte al dramma palestinese, la voce ancora più saggia della poesia lirica. Già nel 2021, aveva pubblicato un'elegia inquietante, intitolata Il vecchio uomo, tradotta poi in sette lingue. Desperatamente attaccato alla speranza, vi scrive: "Ho fatto il giuramento / Di costruire / Sul volto degli assenti ... / L'anima tenace di un bambino ... / Un cielo pacifico e fraterno sulle sue spalle".
Ecco che ricade in un poema ancora più breve, pubblicato simultaneamente in arabo e in francese, Disegnami una Palestina felice (Al Manar, 2025). In un slancio utopico, al contempo sognante e ironico, affettuoso e dignitoso, ostinatamente attaccato alla vita e risolutamente ancorato a un'etica umana, l'autore si proietta in una descrizione ordinaria dell'(im)possibile.
"Disegnami una Palestina
Con contadini nei campi
E gente che si affolla nei bus
nelle ore di punta".

Driss Ksikes è scrittore, autore teatrale, ricercatore in media e cultura
e preside associato alla ricerca e all'innovazione accademica presso HEM
(università privata in Marocco).
Foto di copertura: ©Ahmad-Ardity-Pixabay