Sapevate che oltre il 95% delle comunicazioni internazionali e dei trasferimenti di dati dipendono dalle reti di cavi sottomarini globali? All'inizio può sembrare un fatto curioso: che strano, la tecnologia più avanzata e rivoluzionaria del nostro tempo non si basa sui satelliti, ma scorre sul fondo del mare (perché poi associamo sempre la modernità allo spazio?). Ma se ci prendiamo il tempo di considerare tutto ciò che nella nostra vita dipende ormai da questa tecnologia — finanza, diplomazia, sicurezza, cooperazione internazionale — la sua importanza strategica diventa evidente.
Di Ada Ferraresi
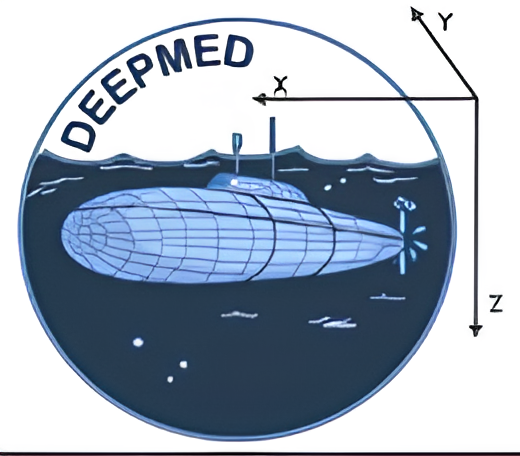
Questo articolo si inserisce nel programma di ricerca Deepmed/ ERC (European Research Council) coordinato da Lino Camprubí dell'Università di Siviglia.
In un clima geopolitico teso come quello attuale, le rotture dei cavi sono sempre più spesso attribuite ad atti di sabotaggio. Nel 2022, ad esempio, la rete mondiale ha subito un colpo a causa di rotture intenzionali di cavi sottomarini nel sud della Francia – Marsiglia è un hub globale di dati sottomarini. Sono seguite accuse di sabotaggio russo. La vulnerabilità di questa infrastruttura sottomarina sta allarmando governi, aziende e media. Come si può leggere su un articolo di The Guardian, questi sospetti attacchi hanno messo "i paesi europei in stato di massima allerta."
Sebbene tanto allarmismo non sia sorprendente, è in parte inopportuno e potenzialmente pericoloso. Gran parte del discorso attuale implica che questa minaccia sia nuova, alimentata dalla crescita esponenziale del traffico Internet globale dal 2013. Eppure i sistemi di cavi sottomarini esistono dal XIX secolo. Il primo fu posato nel 1850 tra Dover e Calais, seguito otto anni dopo dal primo cavo transatlantico. In pochi decenni, gran parte del globo era connessa da reti sottomarine, per lo più controllate da aziende britanniche.
La strategia militare della sabotaggio
Inoltre, manca in questi resoconti la consapevolezza che la strategia del sabotaggio è antica quanto la comunicazione sottomarina. In un recente articolo specializzato si legge: “Attività precedentemente sconosciute – come … l'uso di pescherecci come forze paramilitari; o l'esplorazione e il pattugliamento delle acque di altre nazioni come mezzo per estendere rivendicazioni di sovranità - sono esempi di come Pechino stia guadagnando terreno nella zona grigia mentre i suoi avversari stanno ancora cercando di inquadrare il problema nelle loro categorie ben ordinate di leggi e norme.”
Storicamente, tuttavia, queste attività non erano solo note, ma ampiamente accettate come strategie militari legittime. Durante la prima guerra mondiale, le forze britanniche, austriache, tedesche e italiane hanno tutte preso di mira i cavi sottomarini come strategia militare principale. L'ingegnere italiano Emanuele Jona descrisse il blocco telegrafico della Germania da parte dell'Inghilterra come "silenzioso", come un "blocco implacabile, inevitabile, preciso e sicuro — come un fenomeno astronomico: un blocco gravido di gravi conseguenze — il blocco delle comunicazioni telegrafiche con il mondo intero.”
Ha descritto in dettaglio diversi episodi di sabotaggio: i tedeschi che tagliavano i cavi dall'Africa all'Australia, gli austriaci che tagliavano le linee vicino alle isole Tremiti e le forze italiane che prendevano di mira i cavi ottomani che collegavano Costantinopoli alle città del Mediterraneo orientale. Un operatore italiano ricorda l'ordine di tagliare il cavo austriaco tra Trieste e Corfù—"l'unico cavo ancora operativo tra i nostri nemici. I cavi tedeschi a nord erano stati tutti tagliati dai britannici poche ore dopo la dichiarazione di guerra con la Germania.” Il sabotaggio dei cavi è diventato una tattica militare precoce e diffusa nei conflitti successivi all'avvento del telegrafo sottomarino, utilizzata da tutte le nazioni, non solo quelle nelle zone grigie della guerra moderna.
Di conseguenza, le preoccupazioni riguardo al sabotaggio dei cavi sono comprensibili nella misura in cui la scena geopolitica di oggi si avvicina a acque pericolose. Tuttavia, non devono essere intese come preoccupazioni per una nuova minaccia: viviamo sotto la minaccia del sabotaggio dei cavi sottomarini da 200 anni! In effetti, il sabotaggio è così antico che nel 1884 fu firmata la Convenzione internazionale per la protezione dei cavi, che è tuttora il principale quadro normativo a riguardo.
Le comunicazioni, le prime vittime di guerra
Più preoccupante della minaccia stessa è il discorso che la riguarda: i cavi sottomarini sono presentati come se si sviluppassero indipendentemente dalle società che li hanno creati, spinti solo dalla crescente domanda di Internet. Sembrano autonomi - vulnerabili, ma implacabili. E se la tecnologia è percepita come indipendente, lo sono anche le leggi che la regolano. A tal punto che, durante il workshop 2024 dell'International Cable Protection Committee (ICPC) sul diritto del mare e i cavi sottomarini, quando si è trattato di discutere “se gli Stati hanno il diritto di tagliare cavi in caso di conflitto armato”, è stato stabilito che, “per ragioni storiche, i cavi non sono considerati neutrali e potrebbero essere le prime vittime della guerra”. Questa vulnerabilità, quindi, non è inevitabile, ma riflette scelte giuridiche e politiche fatte nel corso di due secoli. La legge è fatta dagli esseri umani e può essere cambiata; la fragilità della rete è una questione di volontà, non di destino. Il punto è che i vantaggi dell'ambiente sottomarino hanno sempre superato gli ostacoli fin dall'inizio.
Malgrado la sua inaccessibilità, lo spazio sottomarino ha permesso per lungo tempo alle potenze terrestri di agire con discrezione — nascosto dalle onde, per così dire. Ciò è particolarmente vero per uno spazio geopoliticamente e topograficamente complesso come il Mediterraneo.
Nel XIX e XX secolo, le aziende britanniche detenevano un quasi-monopolio mondiale sul telegrafo sottomarino e venivano spesso incaricate di costruire reti sottomarine per altri Stati. Nel caso dell'Impero ottomano, che non disponeva del know-how tecnologico per la posa di cavi sottomarini, le aziende britanniche non solo installarono l'infrastruttura, ma acquisirono anche una conoscenza dettagliata della sua geografia. Questo diede alla Gran Bretagna un accesso privilegiato a informazioni altamente strategiche.
Durante la guerra italo-turca (1911-12), combattuta per il controllo della Libia, tagliare i cavi nemici fu una tattica militare essenziale. Sebbene la Gran Bretagna fosse rimasta neutrale, ufficialmente, aiutò discretamente l'Italia: già nel 1900, la nave posacavi italiana Città di Milano ricevette mappe britanniche che mostravano la posizione dei cavi mediterranei. Un operatore dell'epoca annotò: "due rappresentanti della English Cable Company salirono rapidamente a bordo … lasciandoci in carico una custodia di metallo contenente mappe nautiche con le rotte di tutti i cavi che formavano la loro vasta rete mediterranea." Che ciò sia avvenuto più di un decennio prima della guerra suggerisce una lungimiranza strategica. L'Impero britannico appariva neutrale in superficie, ma in realtà tracciava confini a proprio vantaggio. Dovremmo concentrarci sull'ambiente sottomarino, non perché celi nuove minacce, ma perché la sua natura fluida e spesso opaca ha permesso per secoli di realizzare manovre geopolitiche incontrollate al di fuori di ogni controllo.
Uno squilibrio nord/sud
Infatti, poiché la posa di cavi sottomarini è stata una scelta attiva delle società umane sin dal XIX secolo, sono state anche messe in atto misure di contro-sabotaggio. Consapevoli della vulnerabilità dell'ambiente, le aziende spesso installano più rotte per garantire la ridondanza. Posare cavi è costoso, ma i grandi attori di oggi — Google, Meta, ecc.—possono permetterselo. Nel frattempo, i paesi del Sud globale dipendono spesso da reti fragili, prive di risorse o di interesse strategico.
Le reti europee, al contrario, sono robuste e ben ramificate; non sono sotto una minaccia esistenziale. Se mai, sono le aziende occidentali che hanno contribuito a produrre disparità globali in termini di connettività. Anche se Russia e Cina intraprendono azioni di sabotaggio, come hanno fatto altri, è improbabile che l'Europa debba affrontare gravi perturbazioni. È significativo che l'articolo del Guardian “L'Europa è sotto attacco?” citi solo esempi extraeuropei di impatto grave:
“Nel 2023, l'interruzione dei collegamenti via cavo tra le isole Matsu e Taiwan nel mare Cinese orientale … ha lasciato 14.000 persone senza accesso a Internet per diversi giorni … Nel mare Rosso, l'interruzione di quattro cavi ha disturbato il 25% del traffico di dati tra l'Asia e l'Europa.
Questo squilibrio tra le reti ben protette del Nord globale e l'accesso precario nel Sud globale ci porta verso una regione in cui queste tensioni diventano particolarmente evidenti: il Mediterraneo. Oggi, il mar Mediterraneo è posizionato come una porta digitale tra Europa e Africa, un hub strategico che collega i continenti. Ma dietro il linguaggio dell'innovazione e dell'integrazione regionale si nasconde una realtà più complessa. Gran parte delle infrastrutture che consentono questa trasformazione — cavi come il BlueMed e progetti come Medusa — è detenuta o gestita da aziende europee e occidentali. Anche se paesi come la Libia esprimono ambizioni di sovranità digitale, il loro accesso alle reti globali è mediato da sistemi che non controllano completamente.
Per andare avanti, dobbiamo prestare maggiore attenzione alla storia delle infrastrutture sottomarine, non per alimentare la paura, ma per sensibilizzare su come le reti globali abbiano a lungo riflesso e rafforzato gli squilibri di potere. Dovremmo concentrarci sugli spazi in cui attori diseguali interagiscono più direttamente, spazi come il Mediterraneo, dove il capitale globale, le ambizioni nazionali e le asimmetrie storiche convergono in modo sorprendente. Sul fondo del mare si trovano non solo la tecnologia, ma le tracce di antichi imperi, nuove dipendenze e la politica del futuro.

