Quest'isola italiana, avamposto verso la Tunisia e l’Africa, è nota nell’attualità per le sue crisi e i suoi drammi, legati soprattutto agli sbarchi dei migranti provenienti dal Mediterraneo. È meno noto invece come Lampedusa sia stata a lungo un’isola rifugio, un « luogo sacro condiviso » da cristiani e musulmani, che vi hanno trovato lì un vero porto sicuro…
Il suo nome risuona frequentemente nei media, associato a una triste litania di tragedie e sofferenza umana, a un numero impressionante di naufragi, morti e superstiti. Tuttavia, questo minuscolo territorio italiano di appena 20 chilometri quadrati, sperduto da qualche parte tra la Sicilia e la Libia, è conosciuto solo in modo superficiale. Sembra affiorare da un passato nebuloso, dal momento in cui i riflettori dell’attualitàlo hanno illuminato. Eppure, un viaggio nella storia di questo isolotto riserva molte sorprese e colpi di scena. Insomma, esiste davvero una Lampedusa prima di « Lampedusa », per così dire.
Lampedusa prima di Lampedusa
Nel corso dei secoli, il destino dell’isola è stato legato all’acqua che la circonda. Risalendo indietro nel tempo, si scopre che è sempre stata un importante crocevia marittimo, un nodo essenziale per la circolazione delle persone. Sin dal Medioevo, e per almeno sei secoli, Lampedusa è stata un luogo di passaggio in uno spazio marittimo fortemente diviso tra cristiani e musulmani. Inabitata, questa roccia piantata tra le onde gode di una posizione strategica e, grazie alla sua neutralità, diventa un punto di sosta imprescindibile per le imbarcazioni, che vi trovano acqua, legna e cibo. Aperta, generosa, dispensatrice di cibo, l’isola offre anche riparo nelle sue insenature a qualsiasi nave in difficoltà durante le frequenti tempeste che si abbattono sul mare. Cicatrice infinitesimale sulla pelle liscia dell’acqua, Lampedusa è uno spazio vuoto eppure cruciale. Una sorta di ombelico segreto del Mediterraneo.
Un santuario condiviso
Inoltre, qui sorge un dispositivo simbolico sorprendente, che si inserisce nel lungo periodo. Una piccola grotta, nascosta nelle pieghe del territorio, ospita un culto singolare. Una metà di questa cavità è riservata alla venerazione di un’immagine della Vergine, l’altra a quella di un santo musulmano, di cui ospita la tomba. I molti marinai che fanno scalo sull’isola non mancano mai di onorare questo piccolo santuario, senza distinzione di religione.
Le origini di questa tradizione sono remote. Quando le prime testimonianze emergono nelle fonti scritte, a partire dalla seconda metà del XVI secolo, rivelano una tradizione già ben radicata. Da allora, nel corso dei decenni, molti testimoni hanno regolarmente manifestato la loro sorpresa di fronte alla situazione che scoprivano nella grotta, dove si accumulavano numerose offerte depositate da devoti cattolici e musulmani: monete, anelli, ciondoli, diademi, ceri, candele… Un assortimento che comprendeva anche vestiti e diversi tipi di utensili. Senza contare la presenza di cibo, sotto forma di pane, formaggio, carne salata.
I principali destinatari di queste provviste sono gli schiavi fuggiaschi o i naufraghi, sia cristiani che musulmani. Grazie a esse possono sopravvivere, in attesa che una nave attracchi e li accolga a bordo: non è necessario, in quest’isola deserta, possedere l’astuzia di un Robinson Crusoe per sopravvivere in solitudine. Grazie alla solidarietà collettiva, il necessario è messo a disposizione di chiunque si smarrisca qui. A loro volta, i marinai di passaggio hanno il diritto di servirsi degli oggetti riposti nella grotta, ma devono restituirli oppure depositare l’equivalente del loro valore. Secondo una credenza che tutti condividono, indipendentemente dalla loro religione di appartenenza, coloro che infrangerebbero questa legge tacita, appropriandosi indebitamente di qualcosa, non sarebbero più in grado di lasciare Lampedusa, poiché il vento e la tempesta si scatenerebbero contro le loro barche.

Un luogo di incontro pacifico tra cristiani e musulmani
Quest'isola resta uno spazio di incontro pacifico in un mare infestato da antagonismi ostinati e scontri bellicosi, dove la violenza può esplodere in qualsiasi momento. Con il suo paesaggio sobrio ed essenziale, Lampedusa è una zona di contatto, una transizione, una soglia. Solitaria in alto mare, offre l’esperienza di un limen. Approcciare le sue rive, addentrarsi fino alla grotta-santuario, equivale a una traversata verso l'altrove. Nel suo paesaggio di sole e vento, l’isola permette un incontro intimo e pacificato con l’altro. Incoraggia una tregua delle ostilità che arriva fino all’aiuto reciproco tra nemici.
Il miracolo di Lampedusa non ha registi ufficiali. Nessun impresario ecclesiastico vi ha messo mano. Il santuario e le tradizioni ad esso collegate sono il risultato di una creazione spontanea e anonima: l’opera di marinai, schiavi, corsari. Tuttavia, la fama dell’isola percorre tutti gli angoli del mare. La Madonna di Lampedusa ha i suoi devoti a Marsiglia come a Livorno, a Tunisi come a Tripoli.
La sorprendente convivenza tra religioni, stabilmente insediata su quest’isola lontana, diventa presto familiare al pubblico colto in Europa. Nel XVIII secolo, Lampedusa fa il suo ingresso nei salotti parigini dove si riunisce l'élite intellettuale dell'Illuminismo. Simbolo di apertura religiosa, a cui si fa riferimento in modo spesso indiretto, si insinua nelle riflessioni delle menti più acute del secolo e si intrufola in alcune pagine di autori di spicco, come Denis Diderot o Jean-Jacques Rousseau.
Questa lunga storia dal fascino fiabesco e mitico si conclude verso la metà del XIX secolo, quando il Regno delle Due Sicilie inizia la colonizzazione dell’isola. La grotta-santuario viene allora ristrutturata e scompaiono le installazioni legate al culto musulmano. La tradizione della condivisione interreligiosa finisce e il mito di Lampedusa si addormenta.
Un’isola di frontiera
Oggi, tornata isola-confine, Lampedusa ha recuperato la sua antica vocazione di luogo di transizione e di contatto. È tornata a essere un limen, ma in uno spazio sovraffollato, un autentico bazar della differenza, dove a fatica coesistono gruppi disparati e spesso antitetici: migranti, turisti, popolazione locale, militari, funzionari dell’UE e dell’ONU, personale delle ONG, attivisti, artisti... In questo improbabile magma si scorgono i semi di nuove pratiche di apertura e di pace. Esse mirano a prevenire i naufragi, soccorrere le imbarcazioni in difficoltà, assistere i superstiti, onorare i morti, preservare il più possibile la loro memoria… Volontari giunti da lontano e segmenti della popolazione locale si sforzano insieme di restituire un po’ di umanità alla frontiera, resistendo alla trasformazione del mare in un muro di filo spinato.
Lampedusa è tornata. Ancora una volta, come in un lontano passato, un’elaborazione collettiva, dal basso, converge qui e dà forma a un’isola aperta. Ancora una volta, come nel secolo dei Lumi, Lampedusa è qui per interpellare la coscienza europea.
Dionigi Albera, antropologo, direttore di ricerca emerito al CNRS, è l’ideatore del programma di ricerca su “I luoghi santi condivisi” è uno dei Commissari della mostra dallo stesso nome, di cui una nuova versione sarà presentata a Roma, alla Villa Medici, nell’autunno del 2025.
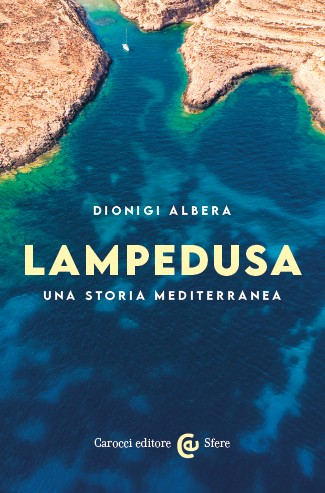
Foto di copertina : La porta d’Europa situata nel punto più a sud dell’isola, è un monumento dedicato ai migranti morti e dispersi in mare ©Dionigi Albera
