Il Mediterraneo è uno spazio rappresentativo delle migrazioni nel mondo. Questo argomento, mediatico e politicizzato, è oggetto di semplificazioni e luoghi comuni proprio nel momento in cui, da una trentina d'anni, diventa sempre più complesso e diversificato.
È al centro di questo dialogo tra Bernard Mossé, responsabile scientifico di NEEDE Mediterraneo, e Andrea Calabretta, sociologo esperto di migrazioni nel mondo, nel Mediterraneo e in Italia in particolare. Per comprendere meglio questa problematica complessa.
Da seguire per cinque settimane.
# 4 In Italia, dal 2010, il contesto geopolitico ed economico esacerba la concorrenza tra gruppi migranti e gruppi stabiliti.
Bernard Mossé: Se non ti dispiace, terminiamo con un tema al centro della tua ricerca: la costruzione dell'identità collettiva dei migranti, il loro rapporto con le popolazioni locali e con la propria comunità. Magari attraverso gli esempi che hai studiato dei tunisini in Italia?
Andrea Calabretta: Abbiamo parlato dei migranti che sono vittime delle categorie che utilizziamo per definirli, e anche delle istituzioni che politizzano e criminalizzano la loro presenza. Ma queste questioni interessano tutta la società civile, le associazioni e l'opinione pubblica: è una chiave per comprendere dinamiche molto tipiche nella costruzione dei gruppi, basandosi ancora sui sociologi Sayad ed Elias.
Per iniziare, è necessario affrontare un'illusione: la percezione del migrante come individuo "temporaneo". In primo luogo perché il migrante stesso non vuole tradire le proprie origini; in secondo luogo perché la società ospitante lo considera come manodopera che risponde a un bisogno provvisorio che non richiede l'integrazione nella cittadinanza politica. E persino lo Stato d'origine non vuole considerarlo perso per la propria popolazione nazionale.
Questa illusione ha conseguenze sulla rappresentazione del migrante, come individuo temporaneo, marginale, che non fa parte della comunità, e sulla rappresentazione di sé: è un processo di esclusione simbolica che porta a esclusioni sociali.
C'è un fenomeno noto nelle scienze sociali che Norbert Elias ha analizzato: quando un nuovo gruppo sociale inizia un processo di stabilizzazione, i gruppi dominanti cercano di ripristinare le differenze, di ripristinare una distanza. Si ha questo conflitto, si potrebbe dire, tra gruppi che si affermano come parte delle società europee, che aspirano a una vita normale, e gruppi dominanti che cercano di mantenere il loro potere e di negare l'ingresso a coloro considerati stranieri. Questi ultimi costruiscono una differenza culturale, etnica, religiosa per distanziare i migranti e i loro discendenti nei discorsi pubblici. Ho osservato questo processo di differenziazione con un gruppo di tunisini in Italia, a Modena, vicino a Bologna.
Questa comunità tunisina è stata fondata negli anni '80. Questi lavoratori tunisini si sono integrati nel tessuto industriale, hanno affittato e poi acquistato case, hanno portato le loro mogli e i loro figli, hanno amici italiani, amici di altre comunità, ecc. Si sono integrati nella vita cittadina, anche se in una posizione un po' marginale di operai e stranieri.
Nel 2011, ci sono due nuovi elementi. Il primo è la crisi economica di quegli anni che colpirà pesantemente il mondo dell'industria con una grande ondata di disoccupazione. Anche le persone immigrate, anche se sono a Modena da decenni, sono comunque considerate straniere e quindi le prime a perdere il loro lavoro... L'idea dell'interdipendenza, che in un certo senso sono utili per la società locale, si perde.
Il secondo evento sono le Primavere arabe. Molti giovani tunisini fuggono dalla Tunisia e arrivano in Italia senza sempre avere un progetto migratorio molto preciso: centinaia di loro passano per Modena. C'è quindi una grande mediaticità, una politicizzazione di questa presenza. Questi giovani tunisini sono considerati criminali. Si vede molto chiaramente come la differenza etnica, il fatto di essere tunisini, che non era un problema nel 2008, lo diventa nel 2012. È una differenza molto importante che ha conseguenze concrete sulla possibilità di trovare alloggio, trovare lavoro. E non riguarda solo i nuovi arrivati, ma anche le persone che erano lì da 30 anni.
È su questo che volevo concludere: si pensa che queste distinzioni nazionali o culturali siano naturali ed evidenti, ma non è così. Sono distinzioni costruite nel tempo, sulla base di conflitti, in base ai contesti e alle differenze di potere. Penso che i rapporti tra i gruppi delle società mediterranee e le società europee potrebbero essere meno tesi, meno violenti, attraverso una ricomposizione globale delle alleanze sociali. Durante il Covid, ad esempio, non c'era questa grande retorica attorno alla migrazione. Il nemico della nostra società era altrove. La ricomposizione sociale generata dalle migrazioni sarà un lavoro lento di modifiche delle gerarchie sociali, coinvolgendo anche la rivendicazione da parte dei discendenti del loro posto nelle società in cui vivono... Sarà lungo e conflittuale, a causa delle resistenze dei gruppi stabiliti, ma è inevitabile.
Bernard: Vorrei affrontare un argomento che non hai menzionato nel tuo lavoro, indipendente dal contesto geopolitico ed economico: il fatto che, all'interno dello stesso gruppo di immigrati - la sociologa Sylvie Mazzella ha osservato questo anche per i tunisini di Marsiglia -, esista una distanza. Sulla base di ciò che ha chiamato "il vicino teppista", il tunisino più giovane, appena arrivato, da cui bisogna distinguersi. Un po' sul tema del luogo comune: l'ultimo arrivato chiude la porta.
Andrea: Sì, è un fenomeno molto comune. Ho notato questo anche a Modena, era molto evidente. Dal mio punto di vista, è una dinamica legata a questa questione delle gerarchie sociali. Per i tunisini che si erano integrati nella società locale, essere assimilati ai nuovi arrivati era considerato negativo. Mi dicevano "Non abbiamo nulla in comune; quando li vedo per strada, cambio direzione...". Si tratta di differenziarsi dall'immagine stereotipata che riguarda i migranti. Ma la cosa molto interessante è l'impossibilità di uscire da queste visioni culturaliste, etnicizzate, di uscire da questa assimilazione con i nuovi arrivati. Mi ricordo di interviste con giovani donne nate e cresciute a Modena, con l'accento di Modena. Era davvero triste perché, in città, nei bar, eccetera, le interazioni andavano bene finché l'interlocutore non scoprisse che erano di origine tunisina...
Sì, le relazioni all'interno delle comunità straniere sono a volte difficili e conflittuali, ma questa stratificazione interna è dovuta al tentativo dei migranti - stabiliti o nuovi arrivati - di trovare uno spazio nella società locale. Tuttavia, questa società a volte utilizza queste differenze interne per tenerli ai margini.
Biografie

Andrea Calabretta è un ricercatore postdoc presso l'Università di Padova (Italia), dove tiene corsi sulle metodologie di ricerca qualitativa in sociologia. Ha conseguito il dottorato nel 2023 con una tesi sulle relazioni transnazionali tra la comunità tunisina in Italia e il paese d'origine, basata sull'applicazione delle teorie di Pierre Bourdieu. Oltre alle relazioni con il contesto d'origine, ha lavorato sui processi di inclusione ed esclusione sociale che influenzano i migranti e i loro discendenti, i loro percorsi lavorativi nella società italiana e i processi di costruzione dell'identità dei migranti.
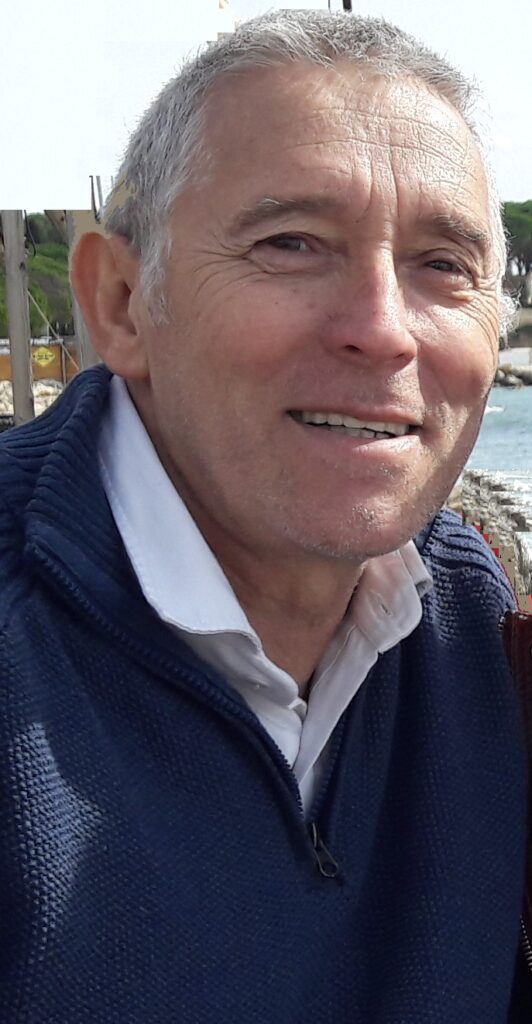
Bernard Mossé Storico, responsabile della Ricerca, dell'Istruzione, della Formazione dell'associazione NEEDE Mediterraneo. Membro del Consiglio scientifico della Fondazione del Campo dei Mille - Memoria ed Educazione, per la quale è stato responsabile scientifico e coordinatore della Cattedra UNESCO "Educazione alla cittadinanza, scienze umane e convergenza delle memorie" (Università di Aix-Marseille / Campo dei Mille).
Bibliografia Appadurai Arjun (2001), Dopo il colonialismo. Le conseguenze culturali della globalizzazione, Parigi: Payot.
Bourdieu Pierre, Wacquant Loïc (1992), Réponses. Pour une anthropologie réflexive. Parigi: Seuil.
Calabretta Andrea (2023), Accettare e combattere la stigmatizzazione. La difficile costruzione dell'identità sociale della comunità tunisina a Modena (Italia), Territori contemporanei, 19. http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/publications/Espaces-Territoires/Andrea_Calabretta.html
Calabretta Andrea (2024), Doubles absences, doubles présences. Le capital social comme clé de lecture de la transnationalité, In A. Calabretta (ed.), Mobilités et migrations trans-méditerranéennes. Un dialogue italo-français sur les mouvements dans et au-delà de la Méditerranée (p. 137-150). Padova: Padova University Press. https://www.padovauniversitypress.it/system/files/download-count/attachments/2024-03/9788869383960.pdf
Castelli Stephen, De Haas Hein e Miller Mark J. (2005 [ultima edizione 2020]), L'età delle migrazioni. Movimenti della popolazione internazionale nel mondo moderno, New York: Guilford Press.
de Haas Hein (2024), “L’idée di grandi onde di migrazioni climatiche è molto improbabile”, articolo su ‘L’Express’.
https://www.lexpress.fr/idees-et-debats/hein-de-haas-lidee-de-grandi-vague-di-migrazioni-climatiche-e-molto-improbabile-K3BQA6QEKRB2JCN4W47VTNCA2Y/
Elias Norbert (1987), Il Ritiro dei Sociologi nel Presente, Theory, Culture & Society, 4(2-3), 223-247. https://journals.sagepub.com/doi/epdf/10.1177/026327687004002003
Elias Norbert, Scotson John L. (1965 [riedizione 1994]), The established and the outsiders. A Sociological Enquiry into Community Problems. Londra: Sage.
Fukuyama Francis (1989), "La fine della storia?" The National Interest, 16, 3–18. https://www.jstor.org/stable/24027184
Mezzadra Sandro, Neilson Brett (2013), Border as Method, Durham: Duke University Press. https://academic.oup.com/migration/article-abstract/4/2/273/2413380?login=false
Sayad Abdelmalek (1999a), La double absence. Dalle illusioni dell'emigrato alle sofferenze dell'immigrato. Parigi: Editions du Seuil.
Sayad Abdelmalek (1999), Immigrazione e "pensiero di Stato". Actes de la recherche en sciences sociales, 129, 5-14.
https://www.persee.fr/doc/arss_0335-5322_1999_num_129_1_3299 Simmel Georg (1908 [riedizione 2019]), L'étranger, Paris

Da questa conversazione, l'IA ha generato un flusso di illustrazioni. Stefan Muntaner l'ha alimentata con i dati editoriali e ha guidato la dimensione estetica. Ogni illustrazione diventa così un'opera d'arte unica attraverso un NFT.
