Il Mediterraneo è uno spazio rappresentativo delle migrazioni nel mondo. Questo argomento, mediatico e politicizzato, è oggetto di semplificazioni e luoghi comuni proprio nel momento in cui, da circa trent'anni, diventa sempre più complesso e diversificato.
È al centro di questo dialogo tra Bernard Mossé, responsabile scientifico di NEEDE Méditerranée, e Andrea Calabretta, sociologo specializzato nelle migrazioni nel mondo, nel Mediterraneo e in Italia in particolare. Per comprendere meglio questa problematica complessa.
Da seguire per cinque settimane.
# 2 - Di fronte alla complessità delle categorie e delle motivazioni degli attori della migrazione, le scienze sociali hanno dovuto adattare i loro strumenti di analisi.
Bernard Mossé: Hai detto che le categorie dei sociologi non sempre coincidono con le categorie amministrative. Puoi darci un esempio di categorie amministrative che vengono ridefinite dai sociologi? E questa è anche un'occasione per chiederti, di fronte a queste mutazioni, come la sociologia e le scienze sociali in generale hanno evoluto nella loro analisi.
Andrea Calabretta: Sì, certo. È una questione epistemologica: noi, sociologi, come operatori delle scienze sociali, come analizza molto bene P. Bourdieu, siamo spinti ad utilizzare e pensare nelle categorie del senso comune e nelle categorie dello Stato. Subiamo questa pressione delle categorie normative, giuridiche, come se fossero oggettive, il che non è il caso: sono categorie anch'esse create socialmente. Ad esempio, non esiste una differenza, come dire, "umana", tra un richiedente asilo e un lavoratore migrante. Siamo chiamati a lavorare su e con persone che vengono categorizzate in questo modo dallo Stato e questa categorizzazione cambia la loro vita. È evidente che questa categorizzazione ha effetti oggettivi sulla vita delle persone. Ma il nostro lavoro consiste anche nel decostruire queste categorie presunte "naturali". È per questo che sono un grande fan del sociologo A. Sayad. Ci porta, fin dagli anni '70, a pensare alla migrazione al di là delle categorie dello Stato. Sappiamo, grazie a lui, che ogni migrazione per lavoro è anche migrazione familiare. Sono categorie che esistono, ma il sociologo deve essere attento a non normalizzarle, a non naturalizzarle. Questa è ancora oggi la mia prospettiva: negli studi migratori, c'è il rischio di essere analitici, di lasciare che le istituzioni indichino cosa deve essere studiato e come nominare le cose. Il grande rischio è quello di non dare a se stessi il potere di nominare gli oggetti di ricerca, perché è proprio questo, la base del nostro lavoro.
Per rispondere alla tua seconda domanda, penso che la sociologia dei fenomeni migratori si sia evoluta negli ultimi anni: abbiamo imparato a lavorare con la complessità. Ci è voluto un po' di tempo perché fino agli anni '80, addirittura '90, avevamo letture piuttosto semplici. C'è stato un grande lavoro di presa in considerazione della complessità e anche il recupero di un pensiero decoloniale.
Bernard: È riduttivo caratterizzare questa evoluzione della ricerca con il fatto che con A. Sayad, collaboratore di P. Bourdieu, il migrante è stato considerato né di qui né di là, seguendo la decolonizzazione, e che oggi il migrante è considerato contemporaneamente di qui e di là, in particolare attraverso l'analisi transnazionale?
Andrea: Secondo me, è un po' riduttivo, sì. Perché nei lavori di Sayad, non c'è solo l'assenza. C'è anche tutta la questione relativa alla presenza, alla permanenza in Francia dei migranti, in particolare algerini, che si traduce in percorsi intergenerazionali nel paese di immigrazione.
In realtà, oggi come ieri negli anni '70, questi due poli dialogano nella vita del migrante: la presenza e l'assenza. Anche se ci sono cambiamenti che li ricompongono. Ad esempio, il cellulare e i social media permettono oggi di mantenere una relazione sociale in senso ampio, comunicativo, simbolico. Ma sarebbe troppo semplificare parlare di "doppia presenza".
A volte, nonostante strumenti di analisi più avanzati, il ricercatore è costretto a semplificare il suo discorso, rispondendo in modo brusco a fenomeni complessi. Questo è particolarmente vero nelle risposte ai programmi di ricerca delle grandi organizzazioni internazionali e alle richieste dei decisori politici. È un po' il rischio che vedo nella sociologia delle migrazioni oggi: semplificare la complessità per soddisfare le esigenze del "mercato" della ricerca.
Bernard: Forse pensi anche tu che sia riduttivo dire che la sociologia degli anni '70 considerava il migrante come una persona che subiva il proprio destino, mentre oggi lo considera più come un attore?
Andrea: No, non è una semplificazione. Penso che effettivamente, come ho detto, gli anni '90 rappresentino un cambiamento nell'immaginario delle migrazioni. Oggi esistono strumenti, individuali, identitari, che spingono i migranti a spostarsi non solo da un paese all'altro, ma nel mondo sociale, in modo diverso rispetto al passato. L'immagine di sé del migrante gli permette di considerarsi più come un attore che come un semplice partecipante di una società ospitante alla ricerca di lavoratori. Sono d'accordo con questo processo di costruzione di attori più attivi nella migrazione.
Anche se a volte esiste un'interpretazione sociologica un po' troppo ottimista e semplificatrice su questo aspetto.
Biografie

Andrea CALABRETTA è un ricercatore postdoc presso l'Università di Padova (Italia), dove tiene corsi sulle metodologie di ricerca qualitativa in sociologia. Ha conseguito il dottorato nel 2023 con una tesi sulle relazioni transnazionali tra la comunità tunisina in Italia e il paese d'origine, basata sull'applicazione delle teorie di Pierre Bourdieu. Oltre alle relazioni con il contesto d'origine, ha lavorato sui processi di inclusione ed esclusione sociale che influenzano i migranti e i loro discendenti, i loro percorsi lavorativi nella società italiana e i processi di costruzione dell'identità dei migranti.
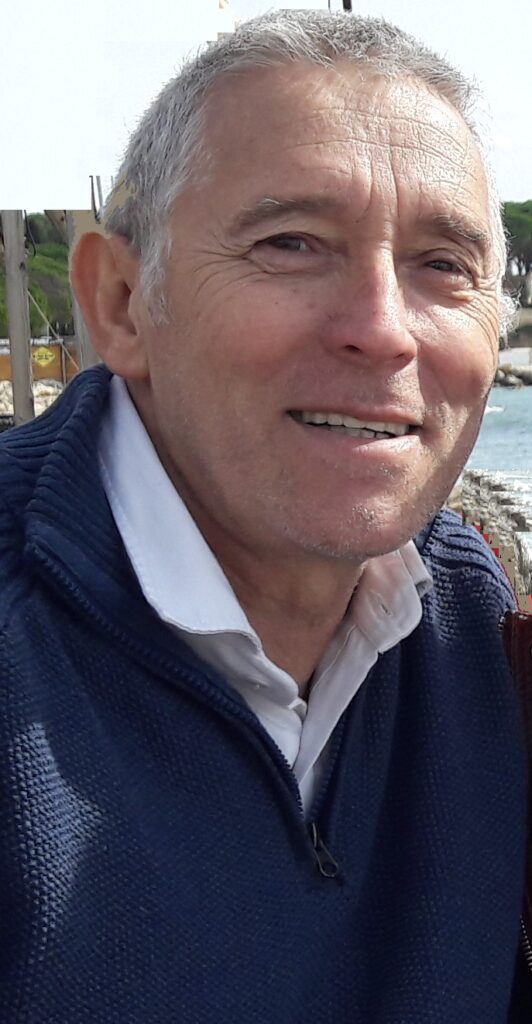
Bernard Mossé Storico, responsabile Ricerca, Educazione, Formazione dell'associazione NEEDE Mediterraneo. Membro del Consiglio scientifico della Fondazione del Campo dei Mille - Memoria ed Educazione, per la quale è stato responsabile scientifico e coordinatore della Cattedra UNESCO "Educazione alla cittadinanza, scienze dell'Uomo e convergenza delle memorie" (Università di Aix-Marseille / Campo dei Mille).
Bibliografia Appadurai Arjun (2001), Dopo il colonialismo. Le conseguenze culturali della globalizzazione, Parigi: Payot.
Bourdieu Pierre, Wacquant Loïc (1992), Réponses. Pour une anthropologie réflexive. Parigi: Seuil.
Calabretta Andrea (2023), Accettare e combattere la stigmatizzazione. La difficile costruzione dell'identità sociale della comunità tunisina a Modena (Italia), Territoires contemporains, 19. http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/publications/Espaces-Territoires/Andrea_Calabretta.html
Calabretta Andrea (2024), Doppie assenze, doppie presenze. Il capitale sociale come chiave di lettura della transnazionalità, In A. Calabretta (a cura di), Mobilità e migrazioni trans-mediterranee. Un dialogo italo-francese sui movimenti dentro e oltre il Mediterraneo (p. 137-150). Padova: Padova University Press. https://www.padovauniversitypress.it/system/files/download-count/attachments/2024-03/9788869383960.pdf
Castelli Stephen, De Haas Hein e Miller Mark J. (2005 [ultima edizione 2020]), *The age of migration. International Population Movements in the Modern World, New York: Guilford Press.
de Haas Hein (2024), “L’idea di grandi onde di migrazioni climatiche è molto improbabile”, articolo su ‘L’Express’. https://www.lexpress.fr/idees-et-debats/hein-de-haas-lidee-de-grandi-vague-di-migrazioni-climatiche-e-molto-improbabile-K3BQA6QEKRB2JCN4W47VTNCA2Y/
Elias Norbert (1987), Il Ritiro dei Sociologi nel Presente, Theory, Culture & Society, 4(2-3), 223-247. https://journals.sagepub.com/doi/epdf/10.1177/026327687004002003
Elias Norbert, Scotson John L. (1965 [riedizione 1994]), Gli stabiliti e gli outsider. Un'indagine sociologica sui problemi della comunità. Londra: Sage.
Fukuyama Francis (1989), “La Fine della Storia?” The National Interest, 16, 3–18. https://www.jstor.org/stable/24027184
Mezzadra Sandro, Neilson Brett (2013), Il confine come metodo, Durham: Duke University Press. https://academic.oup.com/migration/article-abstract/4/2/273/2413380?login=false
Sayad Abdelmalek (1999a), La double absence. Dalle illusioni dell'emigrato alle sofferenze dell'immigrato. Parigi: Editions du Seuil.
Sayad Abdelmalek (1999), Immigrazione e “pensiero di Stato”. Atti della ricerca in scienze sociali, 129, 5-14. https://www.persee.fr/doc/arss_0335-5322_1999_num_129_1_3299 Simmel Georg (1908 [riedizione 2019]), Lo straniero, Parigi.

Da questa conversazione, l'IA ha generato un flusso di illustrazioni. Stefan Muntaner l'ha alimentata con i dati editoriali e ha guidato la dimensione estetica. Ogni illustrazione diventa così un'opera d'arte unica tramite un NFT.
