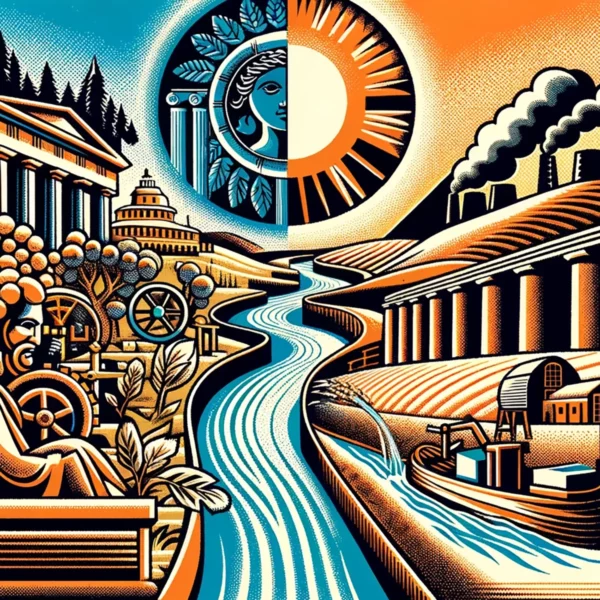Il riscaldamento globale sta scombussolando il ciclo dell'acqua e l'attività umana sta accentuando la carenza di acqua dolce. Le tensioni per il controllo e l'appropriazione di questa risorsa vitale stanno aumentando. Come nel caso del petrolio nel 20° secolo, l'acqua sta diventando fonte di conflitti. È possibile trovare nel passato, soprattutto nelle regioni di cultura fluviale, dispositivi che consentano di risolvere le tensioni tra i vari attori?
Il tema viene affrontato in tre tribune in un dialogo tra gli scienziati Karl Matthias Wantzen* e Bernard Mossé**
Sequenza 3 - La crisi ecologica ci obbliga a costruire una nuova etica
Bernard Mossé: Spesso dici che non basta cambiare i comportamenti, istituire dispositivi di cooperazione, specialmente intorno ai bacini di responsabilità, ecc., ma che tutto questo dovrebbe essere sostenuto da una nuova etica. Hai persino scritto nei nostri scambi "una nuova (antica) etica". Potresti iniziare a delineare i contorni di questa nuova etica o di questo ritorno a un'antica etica?
Karl Matthias Wantzen: Nelle antiche culture, ad esempio le culture celtiche, la natura era considerata un partner. Ma bisogna anche dire che i Celti non erano ancora in grado di dominare la natura allo stesso modo in cui l'essere umano moderno può farlo. Non voglio tornare su alcuni elementi culturali, rivederli, specialmente per quanto riguarda il rispetto per la natura, ma è anche necessario sviluppare una nuova etica basata sia sulla nostra scienza che sulla nostra consapevolezza dell'forte impatto che abbiamo sulla natura: soprattutto integrare il futuro nella presa di decisioni.
L'umanesimo ci ha portato un'idealizzazione dell'essere umano, per vivere meglio. Ma facendo ciò, con la nostra corsa in avanti, abbiamo creato una situazione in cui ci stacchiamo dal futuro. Secondo me, è necessario espandere l'amore che gli esseri umani si dedicano reciprocamente anche verso la natura. Devo lavorare per il benessere del mio "prossimo", ma questo prossimo non dovrebbe essere solo l'essere umano ma anche la natura, credo. Questo è ciò verso cui dobbiamo tendere: avere compassione per la natura, essere proattivi nei suoi confronti, sapendo che è nostro padre, nostra madre, che ci sostiene.
Quindi è necessario ispirarsi, almeno in parte, alle antiche culture che sono state sistematicamente represse, in particolare in Occidente, con, direi, l'ideologia cartesiana, cioè la meccanizzazione e la razionalizzazione dei processi naturali, le scienze e le tecniche di supporto, trascurando gli aspetti emotivi e spirituali dell'essere umano. Possiamo trovarli senza necessariamente cadere in quella nostalgia delle antiche spiritualità sacre.
BM : Se ti ho capito bene, non è necessario tornare a una spiritualità antica, all'ipotesi Gaia sviluppata dal climatologo Lovelock negli anni '70, o all'antica Pacha Mama delle Ande, la Madre Terra, inserita nella Costituzione dell'Ecuador nel 2008. Questa nuova etica che auspichi può essere riassunta da questa frase che la tua connazionale e filosofa Vanessa Weihgold ci ha lasciato nel nostro primo colloquio: dobbiamo sapere cosa la terra ci dà e cosa dobbiamo darle in cambio. Sei d'accordo con questa affermazione?
KMW : Sì, per me, in quanto ecologo, conosco il funzionamento degli ecosistemi, so che le interazioni tra i diversi elementi degli ecosistemi sono molto complesse. Ma con i meccanismi di feedback, posso comunque valutarli e comprenderli meglio. È per me un esercizio privo di religiosità o addirittura di spiritualismo. Devo capire quale leva posso azionare per ottenere un certo effetto. Quali sono i tabù? Scientifici? Se tocchi gli alberi delle teste di bacino, potresti scatenare una catastrofe, una valanga, una siccità, un'inondazione. E dobbiamo integrare questa conoscenza in questa nuova etica. Abbiamo bisogno di un'etica basata sulla nostra comprensione della natura, e siamo molto avanzati. Il vero problema è agire in base alle nostre conoscenze. Possiamo tranquillamente sintetizzare i dati scientifici da un lato e gli insegnamenti degli anziani dall'altro. È stato uno dei risultati più strutturanti del libro che ho curato sulla cultura dei fiumi: ascoltare il canto dei pescatori sul fiume Senegal, significa praticamente comprendere a lungo termine la qualità dell'ambiente del fiume, la sua idrologia, ecc. Il ritmo della natura è lì scritto non con dati idrografici, ma nel testo di una canzone. Non c'è più opposizione tra tradizione e scienza moderna: funziona molto bene insieme.
BM : Ciò che stai descrivendo è affascinante non solo per capire come costruire una nuova etica, ma anche per capire come ripristinare la fiducia nella conoscenza scientifica.
Oppure, in altre parole, quale è la responsabilità dello scienziato nella promozione di una nuova etica?
KMW: I ricercatori devono migliorare la loro capacità di comunicazione. Il nuovo master che sto costruendo includerà almeno il 25% di soft skills, capacità di comunicazione tra i membri del team, in modo interdisciplinare tra i ricercatori, ma anche in modo transdisciplinare, cioè con gli attori sul campo, per comprendere meglio il gioco degli attori.
Ho analizzato la biosfera della Dordogna e la riserva naturale sulla Loira, ho lavorato con le popolazioni in altri siti fluviali in tutto il mondo, ed è sempre la stessa cosa: bisogna prima creare fiducia. Non è solo leggendo una pubblicazione in inglese che descrive la complessità delle minacce che li attendono che le persone mi seguiranno, ma soprattutto dando esempi positivi. Abbiamo molti esempi di fallimenti in cui le buone misure basate sulla scienza non sono affatto state accettate dalle popolazioni. Le persone non erano disposte a sacrificare il loro comfort per un progetto di cui non comprendevano il significato. Ad esempio, pescatori che non erano d'accordo sull'abbandono di una diga a favore di un fiume che garantiva comunque la sostenibilità della pesca per decenni a venire. La comunicazione è molto importante e direi che i ricercatori dovrebbero essere migliori in questo campo. D'altra parte, la popolazione dovrebbe essere in grado di cercare informazioni per una migliore qualità della vita. È necessario organizzare dispositivi che consentano di organizzare il dare e avere, con progetti sviluppati insieme dalle diverse parti interessate: chiamiamo questo "living labs", laboratori viventi, dove si possono mostrare esempi operativi positivi e poi trasferirli, comunicarli da una popolazione all'altra. Ad esempio, una città che ha realizzato un progetto di successo può comunicare ad altre città ciò che ha funzionato bene, quali sono le sfide e come superarle... È ciò che faccio in tutti i miei progetti. Abbiamo sprecato molto tempo ripetendo le stesse ricerche sugli stessi problemi. È necessario che gli esseri umani imparino, imparino a trasmettere e a scambiare.
Per l'intera area del Mediterraneo, è fondamentale un miglior scambio delle buone pratiche, sia tra i paesi mediterranei che tra il Mediterraneo e le popolazioni che vivono più a nord. È molto importante.
Di fronte alla crisi ecologica, la nuova etica da costruire, basata sulle conoscenze scientifiche, è un'etica della comprensione reciproca e della cooperazione.
Biografia
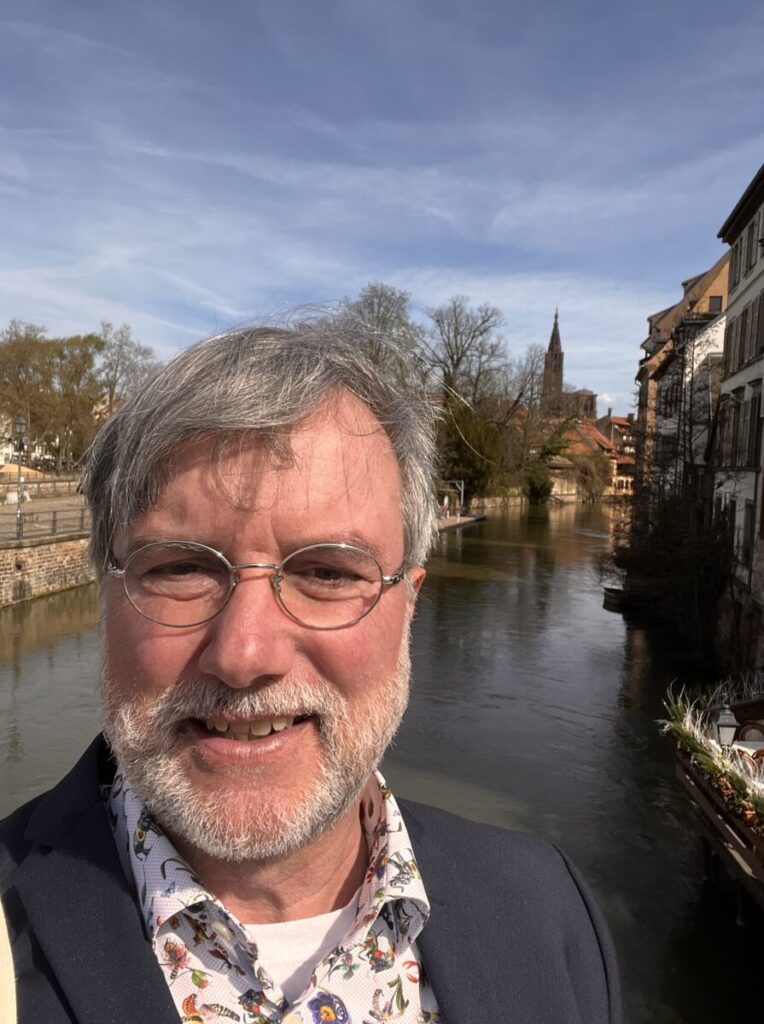
Karl Matthias Wantzen ha studiato biologia presso l'Università di Costanza, ha completato il suo dottorato sulle acque brasiliane presso l'Istituto Max Planck e ha ottenuto l'abilitazione alla ricerca sul tema "Biodiversità e protezione della natura dei grandi fiumi". Per 8 anni ha diretto un progetto di cooperazione internazionale sul Pantanal in Brasile, l'immensa pianura alluvionale del fiume Paraguay.
Dal 2010 è professore in università francesi, prima a Tours, dal 2023 a Strasburgo. Oltre a una cattedra UNESCO "Fiumi e Patrimonio", dirige anche una cattedra interdisciplinare "Acqua e Sostenibilità" per il partenariato universitario trinazionale "EUCOR- The European Campus".
Ulteriori informazioni su https://ites.unistra.fr/recherche/equipes/bise/karl-matthias-wantzen, https://www.unesco-chair-river-culture.eu/
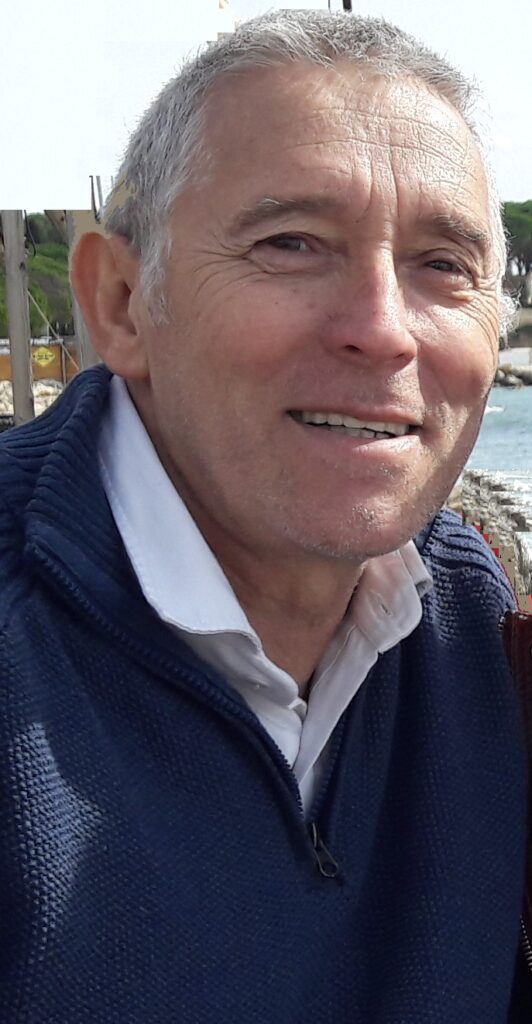
Bernard Mossé Storico, responsabile Ricerca, Educazione, Formazione dell'associazione NEEDE Mediterraneo.
Membro del Consiglio scientifico della Fondazione del Campo dei Mille - Memoria ed Educazione, per la quale è stato responsabile scientifico e coordinatore della Cattedra UNESCO "Educazione alla cittadinanza, scienze dell'uomo e convergenza delle memorie" (Università di Aix-Marseille / Campo dei Mille).