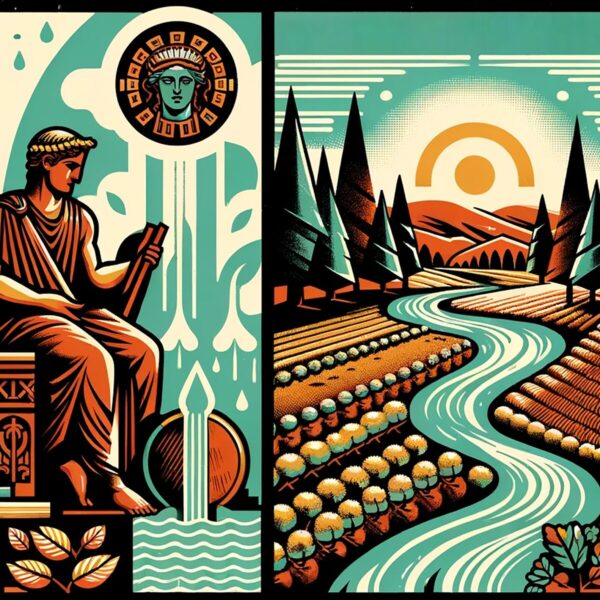Il riscaldamento globale sta sconvolgendo il ciclo dell'acqua e l'attività umana sta accentuando la scarsità di acqua dolce. Le tensioni per il controllo e l'appropriazione di questa risorsa vitale stanno aumentando. Come nel caso del petrolio nel 20° secolo, l'acqua sta diventando fonte di conflitti. È possibile trovare nel passato, in particolare nelle regioni di cultura fluviale, dispositivi che consentano di risolvere le tensioni tra i vari attori?
Il tema viene affrontato in tre tribune in un dialogo tra scienziati: Karl Matthias Wantzen e Bernard Mossé
Sequenza 2 - La mediterraneizzazione dell'Europa del Nord obbliga a rivedere la cooperazione Nord/Sud
Bernard Mossé : Tra tutte le conseguenze, senza dubbio irreversibili, del cambiamento climatico, stiamo assistendo a quella che viene definita la "mediterraneizzazione" dell'Europa del Nord. Puoi dirci qualcosa in proposito? In che punto ci troviamo oggi e a cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi decenni?
Karl Matthias Wantzen : Infatti. I paesi mediterranei dovrebbero invitare tutti i sindaci dei paesi più a nord a visitarli e a osservare la loro situazione, specialmente durante le fasi di carenza, con siccità, incendi boschivi, e anche eventi come quelli che abbiamo visto nel Mediterraneo lo scorso settembre: in Libia sono caduti in 48 ore il doppio delle precipitazioni di un intero anno, causando 3500 morti. E altri drammi in Grecia e in Spagna. È stato davvero catastrofico. La mediterraneizzazione dell'Europa del Nord significa che le condizioni climatiche già conosciute da centinaia di anni, se non millenni, nel Mediterraneo, si stanno spostando verso nord. Quindi non abbiamo più una distribuzione equilibrata delle precipitazioni durante tutto l'anno, e contemporaneamente abbiamo sempre più fiumi prosciugati, con un flusso notevolmente ridotto, un riscaldamento dell'acqua che porta a malattie dovute alla sovrapproduzione batterica, eccetera. E anche episodi torrenziali catastrofici come quelli che abbiamo visto in Germania, o in Belgio, due anni fa, con 134 persone decedute in un paese dove si pensava che la prevenzione delle inondazioni funzionasse. Ma gli eventi superano le nostre capacità di immaginazione e bisogna sviluppare una cultura del rischio, in particolare attraverso scambi Nord/Sud. Gli eventi considerati "singolari" stanno iniziando a diventare "regolari". La normalità sta cambiando. Non solo le popolazioni più a nord devono imparare dalle popolazioni del Sud per prevenire le catastrofi, ma è necessario organizzare la solidarietà tra di loro. Perché le carenze colpiscono ovviamente molto di più nei paesi mediterranei. Una cosa che non viene detta abbastanza è che è davvero necessario prevedere anche abbandoni: abbandoni di alcune colture e pratiche, ma anche di alcune aree agricole. Non coltivare più, ad esempio, fragole e lamponi in Marocco per le bocche europee in inverno... In termini di gestione dell'acqua, di pratica culturale e di solidarietà, è assurdo.
Bernard Mossé : In questo scambio di conoscenze, in questo caso dal Sud al Nord, vedi altre tecniche, altri dispositivi di cui il Nord potrebbe prendere ispirazione?
Karl Matthias Wantzen : Innanzitutto, riconoscere che la risorsa idrica non è inesauribile e gestire la carenza è ciò che il Nord può già imparare; in particolare, essere molto meno avidi nella produzione agricola e anche industriale. La maggior parte dei dirigenti delle grandi imprese ha già compreso questo concetto, ma direi che non è ancora stato integrato a livello di quadri, manager e dipendenti. Gli utenti in generale credono ancora che l'acqua uscirà sempre dal loro rubinetto e che possono sprecarla a volontà. Poiché l'acqua rimane molto economica in quelle regioni, lo spreco ha un impatto molto limitato sulle loro tasche. Ovviamente non sto dicendo che l'acqua dovrebbe diventare molto più cara, ma forse dovremmo punire lo spreco. Sarebbe una buona idea. Ma soprattutto significa che dobbiamo prendere coscienza che, indipendentemente dalla nostra pratica, l'essere umano ha sempre un impatto sull'acqua. Dobbiamo misurare questa impronta ecologica negativa. Quanta acqua devo risparmiare per contribuire a migliorare la situazione idrica. Dobbiamo sempre considerare i bisogni della natura riguardo all'acqua, che sono stati completamente ignorati.
Ma ora che stiamo iniziando a distruggere le basi della nostra sopravvivenza, che le catastrofi si susseguono e si accelerano, iniziamo a riflettere. Ad esempio, nelle montagne come i Vosgi e la Foresta Nera, ora vediamo ettari e ettari di alberi morti perché fa troppo secco, perché abbiamo piantato specie sbagliate. Ma abbiamo anche altri problemi, ad esempio, il drenaggio che porta l'acqua verso il basso e la devia dalle teste di bacino che sono cruciali per il ciclo dell'acqua. È necessario mantenere, ripristinare e ripristinare le zone umide che sono le vere spugne del paesaggio, che riempiono le falde acquifere e forniscono acqua durante le magre. Dobbiamo cambiare persino il nostro vocabolario meteorologico. In televisione si dice: "Farà brutto tempo, pioverà questa settimana". Dovremmo dire al contrario: "pioverà, quindi approfittiamone! è un'opportunità per noi di innaffiare gli alberi a basso costo, per le reti verdi e blu degli spazi verdi delle nostre città"... infatti la vegetazione è in cattive condizioni. Bisogna ripensare completamente a questo e chiedersi dove si trovano le spugne potenziali, soprattutto nel perimetro urbano, e come possiamo utilizzarle. E soprattutto, non credere che basti costruire un serbatoio: è soprattutto importante sapere dove si trova la spugna naturale che ha miliardi di anni di esperienza. Come trovare soluzioni migliori di quelle basate sulla natura?
Bernard Mossé: A questo proposito, quali lezioni possiamo trarre dalla polemica che circonda i mega-serbatoi?
Karl Matthias Wantzen: È una posizione che purtroppo vediamo un po' ovunque. Qualche tempo fa il capo della Camera di agricoltura in Spagna mi ha detto, anche se aveva appena dichiarato che alcune regioni presto non potranno più coltivare viti: "Ci sarà sempre acqua, non dobbiamo cambiare nulla nella viticoltura". Ma sì, bisogna cambiare. E questo cambiamento riguarda le diverse pratiche umane e soprattutto la nostra alimentazione e la nostra agricoltura. Buona parte dell'agricoltura attuale non è più compatibile con il cambiamento climatico. Non biasimo i produttori che devono rispondere alle aspettative dei consumatori, mi lamento piuttosto dei consumatori che vogliono sempre comprare carne a basso prezzo e consumarla sette giorni su sette. Date le impronte idriche nella produzione di carne, è impossibile! È assolutamente necessario ridurre il consumo di carne ma anche ridurre il consumo di altri prodotti agricoli. Parlerei di un consumo "idrovores", come la produzione in Spagna che esporta gran parte delle proprie verdure (e quindi la propria acqua) su camion verso nord anziché tenerle per i locali. Ma poiché l'unica misura è il profitto immediato, vendiamo pian piano il nostro futuro, ovvero quello dei nostri figli.
Breve biografia
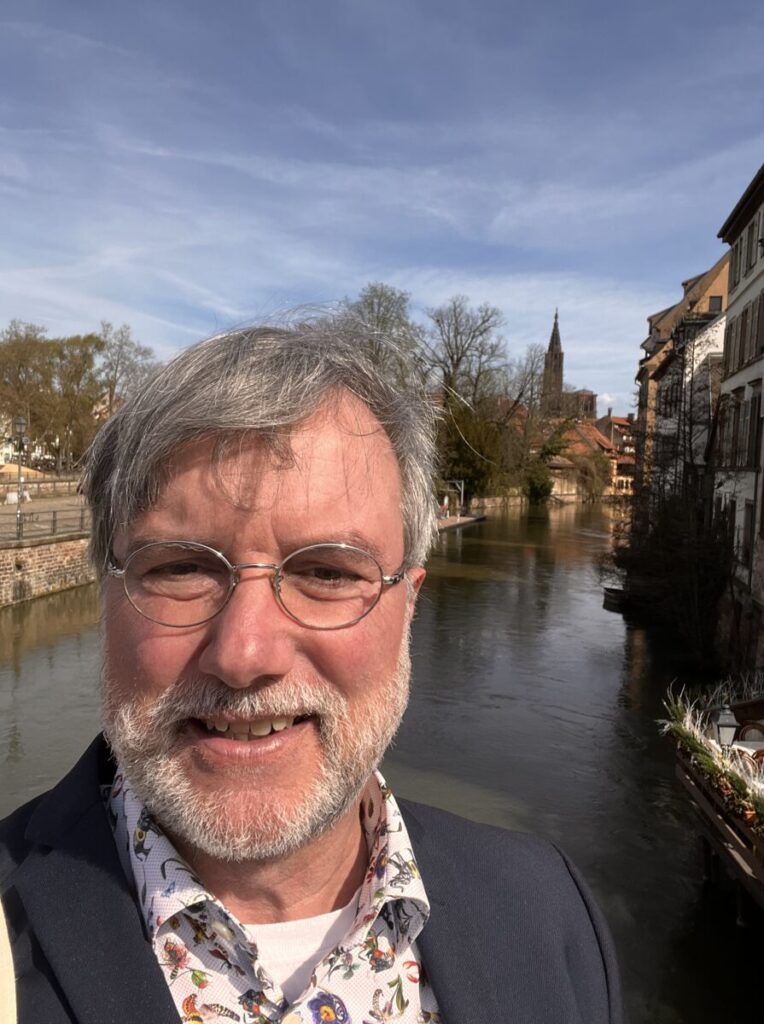
Karl Matthias Wantzen ha studiato biologia all'Università di Costanza, ha completato il suo dottorato sulle acque brasiliane presso l'Istituto Max Planck e ha ottenuto l'abilitazione alla ricerca sul tema "Biodiversità e protezione della natura dei grandi fiumi". Per 8 anni ha diretto un progetto di cooperazione internazionale sul Pantanal in Brasile, l'immensa pianura alluvionale del fiume Paraguay.
Dal 2010 è professore presso università francesi, prima a Tours, dal 2023 a Strasburgo. Oltre ad una cattedra UNESCO "Fiumi e Patrimonio", dirige anche una cattedra interdisciplinare "Acqua e Sostenibilità" per il partenariato universitario trinazionale "EUCOR- The European Campus".
Ulteriori informazioni su https://ites.unistra.fr/recherche/equipes/bise/karl-matthias-wantzen, https://www.unesco-chair-river-culture.eu/

Bernard Mossé Storico, responsabile della Ricerca, dell'Istruzione, della Formazione dell'associazione NEEDE Mediterraneo.
Membro del Consiglio scientifico della Fondazione del Campo dei Mille - Memoria ed Educazione, di cui è stato responsabile scientifico e coordinatore della Cattedra UNESCO "Educazione alla cittadinanza, scienze dell'Uomo e convergenza delle memorie" (Università di Aix-Marseille / Campo dei Mille).