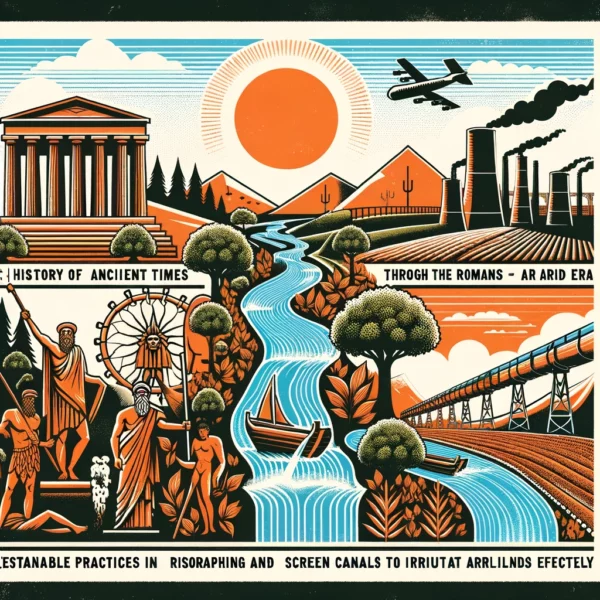Il riscaldamento globale sta sconvolgendo il ciclo dell'acqua e l'attività umana sta accentuando la scarsità di acqua dolce. Le tensioni per il controllo e l'appropriazione di questa risorsa vitale stanno aumentando. Come nel caso del petrolio nel 20° secolo, l'acqua sta diventando fonte di conflitti. È possibile trovare nel passato, soprattutto nelle regioni di cultura fluviale, dispositivi che permettano di risolvere le tensioni tra i diversi attori?
La tematica sarà affrontata nei prossimi tre forum in un dialogo tra scienziati: Bernard Mossé e Karl Matthias Wantzen.
Sequenza 1 - L'impatto dell'attività umana sul ciclo dell'acqua
Bernard Mossé : Puoi fornire una breve spiegazione del ciclo dell'acqua, evidenziando il ruolo dei fiumi in questo sistema?
Karl Matthias Wantzen: Il ciclo dell'acqua comprende l'evaporazione, la formazione delle nuvole, le precipitazioni, il deflusso in superficie o in profondità e infine il ritorno delle acque verso gli oceani, spesso tramite i fiumi. In alcune culture, come nelle Ande in America del Sud, questo ciclo è paragonato al ciclo della vita, con i fiumi che rappresentano la nascita e la morte delle anime. Tuttavia, l'attività umana disturba questo ciclo, soprattutto attraverso l'impermeabilizzazione delle superfici, la riduzione delle aree alluvionali dei fiumi e la deforestazione.
BM : Spesso si individua l'impatto negativo dell'uomo all'inizio dell'era industriale. Possiamo dire che l'attività umana influisce su questo ciclo da molto più tempo?
KMW : Sì, ma bisogna sapere dove e a quale scala. La costruzione di dighe a grande scala sui fiumi porta all'assenza di sedimenti: le foce, chiamate "Delta", si trasformano in forme di "Beta" a causa dell'erosione diffusa e massiccia (solo un terzo dei grandi fiumi può ancora fluire liberamente). Questo è un fenomeno dell'ultimo secolo, e una catastrofe per il funzionamento ecologico e il supporto alla diversità bio-culturale.
Se prendiamo ad esempio il legame tra la vegetazione e l'acqua, quello che viene chiamato "fiumi volanti", cioè l'evapotraspirazione delle piante, che produce una certa umidità nell'aria locale: a seconda della quantità, può avere un impatto molto forte. Ad esempio, per la parte sopra l'Amazzonia, in America del Sud, il 15-20% della pioggia dipende da questi "fiumi volanti". La distruzione di queste foreste primarie ha raggiunto un punto critico. La sua continuazione sarebbe una catastrofe prima per il Sud America e per l'intero pianeta.
Intorno al Mediterraneo, la deforestazione delle foreste è iniziata con le civiltà greche, forse anche prima con i Fenici, e poi i Romani, per costruire le loro navi e fortezze. Hanno anche costruito dighe e acquedotti, e inquinato siti di mineralizzazione. Questo ha certamente avuto un'influenza sul ciclo dell'acqua e sul flusso dei fiumi, ma con un impatto limitato. Negli ultimi secoli, e soprattutto dalla rivoluzione industriale, l'impatto dell'uomo sul ciclo dell'acqua si è intensificato, con l'urbanizzazione, la costruzione di dighe e l'estrazione eccessiva delle risorse.
BM : Per la cattedra UNESCO sui fiumi di cui sei responsabile, crei un collegamento tra le scienze ambientali e le scienze umane e sociali. La carenza di acqua dolce, destinata ad aumentare, è la fonte di tensioni, e persino conflitti, tra diversi attori. Quali soluzioni proponi per risolverle? È possibile trovare nel passato, forse in regioni con una cultura fluviale, dispositivi che permettano di risolvere le tensioni tra i vari attori?
KMW : Per me, la soluzione si trova nel mio concetto di "cultura del fiume". Bisogna trasformare i bacini idrografici, cioè le aree che raccolgono tutte le acque che cadono in una regione, in territori politici. Se mi permetti questo neologismo, bisogna trasformare i territori in "idroterritori", ovvero "bacini di responsabilità". Tutti gli esseri umani e la natura presenti in un bacino idrografico sono soggetti alle stesse condizioni e hanno gli stessi interessi. Ma spesso i territori umani non corrispondono a questa geografia. I fiumi hanno un problema: sono lunghi e attraversano diversi territori che spesso hanno una forma arrotondata. Oltre una certa lunghezza, i fiumi diventano fonte di divisione tra diversi territori. E questo è un errore. Il fiume è vittima della territorializzazione. Bisogna posizionare il fiume al centro del territorio, costruendo paesaggi politici attorno a questa realtà idrologica.
BM : If I understand correctly, tu pensi che l'interesse dell'uomo sia di modellare la sua azione su quella della natura?
KMW : Finché le nostre azioni continuano a disturbare il funzionamento dei paesaggi, sì, assolutamente. Le nostre decisioni su un bacino idrografico -dighe o trasferimento d'acqua tra due bacini idrografici- hanno contemporaneamente un impatto sulla sopravvivenza delle colture, delle specie e sulla qualità delle generazioni attuali e future. Che qualità di vita vogliamo per il futuro?
Stiamo danneggiandolo con una strategia degli utenti che mira solo ai prossimi 5 anni, o vogliamo che i nostri figli abbiano almeno le stesse condizioni che noi abbiamo, o idealmente condizioni migliori, per quanto riguarda l'abbondanza dell'acqua, il livello di inquinamento, la presenza di specie biologiche, ecc. Se sì, dobbiamo cambiare profondamente il nostro comportamento...
Nel mondo ci sono popolazioni con usanze tradizionali perfettamente adatte al ritmo dell'acqua, cioè alla variazione del flusso, tra il livello minimo e le inondazioni naturali. Ma soprattutto in Europa, c'è questa religione della fattibilità e dell'ingegneria che ha finito per provocare impatti sproporzionati. Tornando alla tua prima domanda: i Romani hanno già sconvolto la natura, ma hanno comunque mantenuto le loro attività al di sotto di certi limiti. Oggi, questo limite è stato superato. I fiumi sono stati così snaturati che ci troviamo di fronte a un circolo vizioso: più diventa rara la risorsa, più siamo avidi. È la tragedia dei beni comuni. È necessario sviluppare una responsabilità comune. È ovviamente molto difficile, perché l'essere umano, come specie biologica, reagisce alle minacce immediate. È necessario integrare le previsioni future nelle azioni presenti. E bisogna convincere la comunità affinché ognuno faccia la sua parte, comprese le persone più forti in situazioni di concorrenza. Torno ai bacini di responsabilità: se abbiamo una nazione idrologica, agiremo insieme, perché non vogliamo lasciare indietro i più poveri se vogliamo che questa comunità abbia un futuro sostenibile. Anche se oggi dobbiamo fare sacrifici o abbandonare alcune pratiche, uscire dalla nostra zona di comfort. Questo è ciò che è più difficile: convincere le persone, soprattutto coloro che traggono maggior beneficio dalla situazione attuale. Ma può funzionare con una comunità basata sulla negoziazione, la comprensione delle sfide e il rispetto reciproco. Ho trovato alcuni esempi in giro per il pianeta, in America del Sud, in India e in Africa, e naturalmente anche in Europa. Spesso, sfortunatamente, il catalizzatore di questa comunità è una catastrofe. È quello che è successo per la valle del Reno con un incidente chimico nel 1986: tutti i paesi che si affacciano sul Reno hanno allora ratificato le convenzioni che erano sul tavolo da anni.
BM : Sì, è un parallelo che possiamo fare con i crimini di massa: le coscienze si risvegliano dopo che la tragedia è avvenuta.
KMW : Riguardo alle catastrofi, bisogna fare attenzione, perché ciò che sta accadendo potrebbe essere così potente da poterci sopravvivere, ma forse no. La domanda più specifica è: a quale livello di qualità della vita vogliamo vivere in futuro?
La catastrofe di Sarnen in Svizzera (l'inquinamento del Reno dalle acque dei pompieri a seguito dell'incendio di un'industria chimica) ha eliminato gran parte dei pesci nel fiume e ha interrotto l'approvvigionamento di acqua potabile per diverse settimane. Il problema si è esteso fino al mare. Con interventi, si è riusciti più o meno a risolvere il problema. Ma con la massiccia deforestazione delle teste di bacino, senza reimpianto, senza protezione e con la costruzione di dighe, i danni superano il ciclo di una vita umana: ci sono molte soluzioni, ma non le vedremo. Stiamo condannando le generazioni future a vivere nella scarsità d'acqua per diverse generazioni o per sempre. E questa è la grande responsabilità della nostra generazione oggi. Non possiamo accontentarci di dire "bisogna educare meglio i giovani affinché agiscano meglio". No, è oggi che dobbiamo agire.
Breve biografia
Karl Matthias Wantzen ha studiato biologia presso l'Università di Costanza, ha conseguito il dottorato sulle acque brasiliane presso l'Istituto Max Planck e ha ottenuto l'abilitazione alla ricerca sul tema "Biodiversità e protezione della natura dei grandi fiumi". Per 8 anni ha diretto un progetto di cooperazione internazionale sul Pantanal in Brasile, l'immensa pianura alluvionale del fiume Paraguay.
Dal 2010, è professore presso università francesi, prima a Tours, dal 2023 a Strasburgo. Oltre a una cattedra UNESCO "Fiumi e Patrimonio", dirige anche una cattedra interdisciplinare "Acqua e Sostenibilità" per il partenariato universitario trinazionale "EUCOR- The European Campus".
Ulteriori informazioni su https://ites.unistra.fr/recherche/equipes/bise/karl-matthias-wantzen, https://www.unesco-chair-river-culture.eu/
Bernard Mossé Storico, responsabile della Ricerca, dell'Educazione, della Formazione dell'associazione NEEDE Mediterraneo.
Membro del Consiglio scientifico della Fondazione del Campo dei Mille - Memoria ed Educazione, per la quale è stato responsabile scientifico e coordinatore della Cattedra UNESCO "Educazione alla cittadinanza, scienze umane e convergenza delle memorie" (Università di Aix-Marseille / Campo dei Mille).
Per andare oltre
Wantzen K.M. (editore), Cultura fluviale, La vita come una danza al ritmo delle acque, Ed. UNESCO, 2023.
Ecco il link: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000382774
Wantzen, K. M. (2022): Cultura fluviale: come si sviluppano i legami socio-ecologici con il ritmo delle acque, come vengono persi e come possono essere riguadagnati. The Geographical Journal, 00, 1–16. DOI: https://doi.org/10.1111/geoj.12476, download gratuito
Ecco il link: https://rgs-ibg.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/geoj.12476
Wantzen, K.M., Ballouche, A., Longuet, I., Bao, I., Bocoum, H., Cissé, L., Chauhan, M., Girard, P., Gopal, B., Kane, A., Marchese, M. R., Nautiyal, P., Teixeira, P., Zalewski, M. (2016): River Culture: un approccio eco-sociale per mitigare la crisi della diversità biologica e culturale nei paesaggi fluviali. Ecohydrology & Hydrobiology 16 (1): 7-18
http://dx.doi.org/10.1016/j.ecohyd.2015.12.003 download gratuito