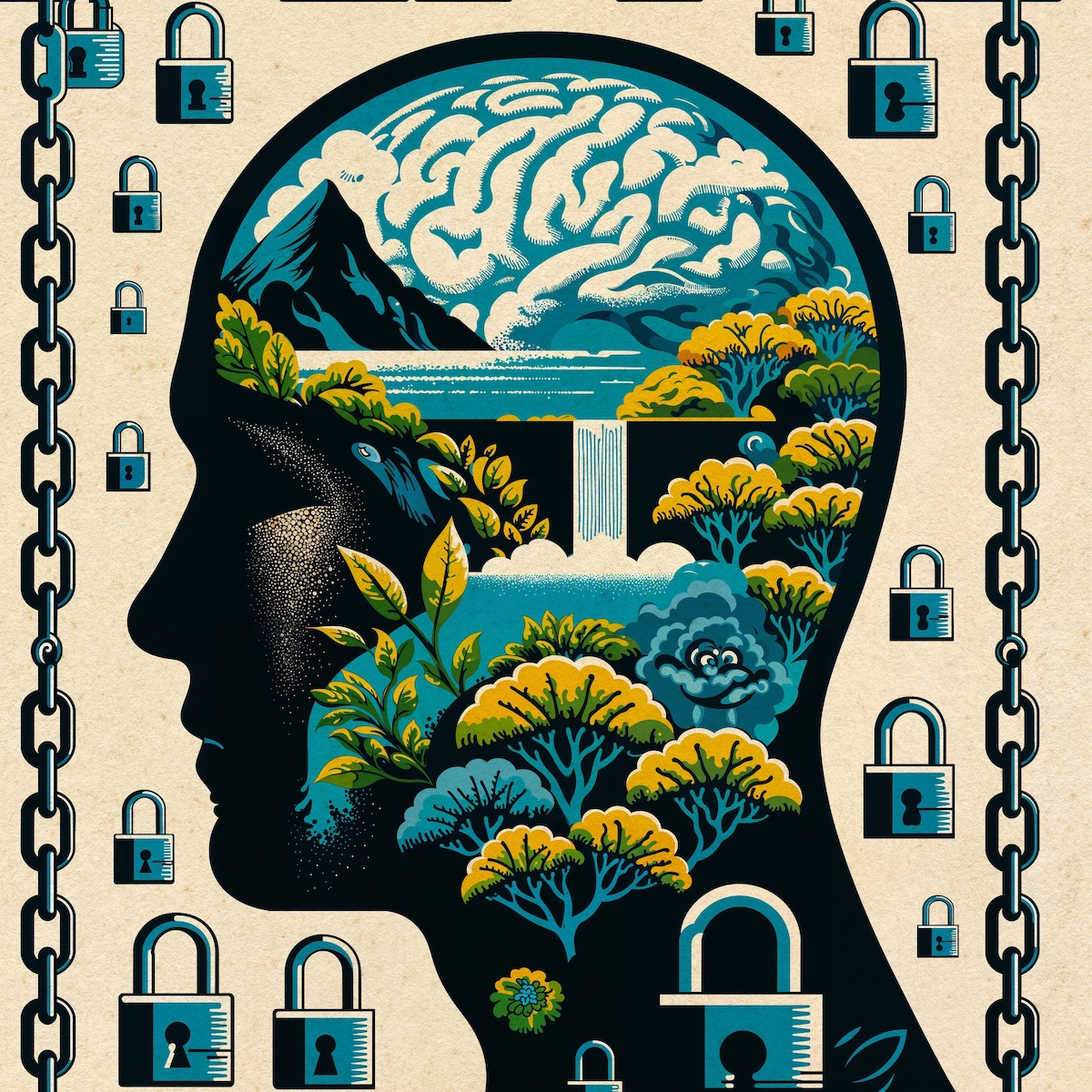Dialogo tra Vanessa Weihgold e Bernard Mossé
Di fronte al cambiamento climatico, alla scomparsa della biodiversità, all'esaurimento delle risorse... la razionalità dovrebbe spingere le popolazioni a modificare il loro comportamento. Tuttavia, considerare la transizione come un'opportunità e non come un vincolo morale o economico entra in conflitto con la nostra cultura e le nostre emozioni.
Nel contesto della transizione ecologica, il conflitto culturale non deve essere inteso come un'opposizione tra culture diverse, ma, all'interno dello stesso paese, della stessa società, come l'opposizione tra le abitudini dominanti, trasmesse per mimetismo, di generazione in generazione, come ad esempio: spostarsi in auto per i propri spostamenti, un'alimentazione basata sulla carne o sui prodotti provenienti dall'allevamento come il latte, o ancora l'acquisto di prodotti confezionati in plastica...
Il conflitto culturale è un ostacolo al cambiamento
Tuttavia, oggi è urgente mettere in discussione questo fondamento comportamentale che ha plasmato la società al termine della Seconda Guerra Mondiale. In quest'urgenza, il ruolo delle emozioni è predominante come luogo di negoziazione con il mondo, in uno scambio reciproco su cui dipende il nostro vivere quotidiano. Ma ciò porta a conflitti, per l'individuo e la società, riguardo ai valori, alle pratiche in una cultura che non è pronta a mettere in discussione il proprio modello. C'è una dissonanza tra ciò che dovrebbe essere fatto e la tendenza naturale a fare come la maggior parte, a rimanere nel confort del "mondo di prima".
Dobbiamo cambiare il narrativo sulla vita, ma anche sul minerale
Tutto ciò che l'essere umano consuma proviene dalla Terra. Per poter continuare a vivere, è necessario che preservi la Natura. Tuttavia, si comporta come un super parassita che utilizza le risorse fino all'esaurimento. La responsabilità sociale richiederebbe che si servisse pensando alla rigenerazione, alla sostenibilità ecologica, all'equilibrio tra l'energia consumata e quella disponibile. In breve, dovrebbe passare da un comportamento di parassita a quello di simbionte che rispetta colui che lo nutre e smetta di parlare della Terra come risorsa.
Questa attitudine predatrice è in contraddizione con il concetto di contratto che implica la reciprocità dei diritti e dei doveri di ciascuna delle parti. Sorge quindi la domanda su quali siano i diritti della Terra e i diritti degli esseri viventi. Questo approccio legale progredisce soprattutto attraverso la Costituzione di alcuni paesi (ad es. la Bolivia). Anche a livello delle istituzioni internazionali con lo status di persona giuridica per le foreste, i fiumi, gli animali. Anche per gli esseri umani, con il diritto di respirare aria pulita, di non essere più contaminati da inquinanti, ecc. Si tratta di una rivoluzione concettuale del rapporto tra l'uomo e il suo ambiente. Ma, più che un contratto, è il concetto di dono e contro-dono che deve legare la Natura all'Uomo.
L’uomo ha preso coscienza della sua vulnerabilità
L'ecoansia è diventato un fenomeno di massa. Gli esseri umani stanno prendendo coscienza che le loro risorse sono limitate e che non potranno più sostenere il modello che ha guidato la crescita e lo sviluppo delle società dalla rivoluzione industriale. Questo mette in discussione tutti i paradigmi del 20o secolo. Una civiltà globale che, se continua, porterà alla fine dell'umanità.
Questa percezione dipende anche dal luogo in cui viviamo. In particolare nel Mediterraneo, hotspot dei cambiamenti climatici, l'aumento delle temperature sta modificando i paesaggi fino al colore delle foglie e alla loro temporalità, provocando, senza lasciare il proprio paese, una sensazione di spaesamento ben studiata dai filosofi: la solastalgia. Questa percezione è soprattutto generazionale. I giovani ritengono che non si stia facendo abbastanza. Non abbastanza velocemente. Che sia il loro futuro che si sta decidendo ora e che è compromesso. Che non sopravviveranno ai cambiamenti ora modellati dagli scienziati. Hanno l'impressione che le azioni, i cambiamenti di comportamento individuali non saranno sufficienti. Che i leader di tutto il mondo non stiano facendo ciò che dovrebbero fare. Da qui l'emergere di movimenti attivisti, sempre più radicali.
Shock and feelings of injustice
L'inazione è attualmente dominante e contagiosa. L'individuo si sente impotente; le imprese sostengono che spetti ai governi fissare gli obiettivi; i governi affermano che cambiare modello è impossibile senza un cambiamento radicale nei comportamenti delle popolazioni. Di fatto, la capacità di agire è frenata, poiché al momento le società più prosperose, che sono quelle che consumano più risorse, non possono, non vogliono, cambiare modello. E coloro che subiscono più massicciamente gli effetti dei cambiamenti climatici sono quelli che hanno meno impatto. Allo stesso tempo, nelle società più consumatrici di risorse, sono le fasce sociali più povere, che beneficiano meno del sistema, a subire di più inquinamento, cattiva alimentazione, ecc. Da qui un sentimento di ingiustizia, che si accompagna a un'altra constatazione: i paesi più industrializzati, Stati Uniti, Cina, Europa, Giappone, sono anche quelli meno inclini a cambiare radicalmente stile di vita. Tuttavia, su un unico pianeta, tutto è interconnesso. Non è perché un paese è virtuoso, produce poche emissioni di CO2, che è al riparo dagli effetti del riscaldamento globale; che si tratti di siccità o, per alcune isole, della loro prevista scomparsa a causa dell'innalzamento del livello del mare. Da qui un sentimento di ingiustizia accompagnato da un'impressione di inevitabilità.
Il cambiamento avviene attraverso un effetto a catena
L'esempio delle imprese è interessante. Quando la dirigenza promuove e adotta un comportamento pro-ambientale e tiene conto delle proposte dei dipendenti, è l'intera struttura che viene trascinata in una dinamica virtuosa. C'è persino un effetto sul reclutamento: i giovani che hanno la scelta perché laureati o formati, ora preferiscono le imprese che vogliono entrare in questo processo. Restituire il potere alle persone è tutta la forza dei movimenti che stanno emergendo e che propongono un modello alternativo. L'approccio partecipativo, locale, è un elemento trainante del cambiamento.
La trasformazione del modello di produzione e consumo può avvenire solo attraverso un cambiamento del modello di società basato su un racconto che ricolleghi l'Uomo al suo ambiente.
*Vanessa Weihgold è una dottoranda in filosofia presso l'Università di Aix-Marseille e l'Università di Tubinga in Germania e sta scrivendo la sua tesi di dottorato in filosofia sulle emozioni in relazione al cambiamento climatico e al degrado dell'ambiente.
Bernard Mossé è un storico, responsabile della Formazione Educazione Ricerca presso l'Associazione NEEDE Mediterranée.
Riferimenti
Norgaard, K.M. (2011): "Vivere nel Rifiuto: Cambiamenti Climatici, Emozioni e Vita Quotidiana", Massachusetts.
Hickman, C., Marks, E., Pihkala, P., Clayton, S., Lewandowski, R.E., Mayall, E.E., Wray, B., Mellor, C. e Susteren, L. van (2021): "L'ansia climatica nei bambini e nei giovani e le loro convinzioni sulle risposte dei governi ai cambiamenti climatici: un sondaggio globale", The Lancet Planetary Health, 5, 12, e863-e873.
Serres, M. (2020): Il contratto naturale, Parigi.
Moore, Jr., B. (1979): Ingiustizia: le basi sociali dell'obbedienza e della rivolta, Londra.
Baptiste Morizot (Morizot, B. (2019): "Questo mal di patria senza esilio. Gli affetti del cattivo tempo che arriva", Critique, n° 860-861, 1, 166-181.)
Sulla relationalità
Kałwak, W. e Weihgold, V. (2022): "La Relazionalità delle Emozioni Ecologiche: Una Critica Interdisciplinare alla Resilienza Individuale come Risposta della Psicologia alla Crisi Climatica", Frontiers in Psychology, 13.
Sul comportamento pro-ambientale sul posto di lavoro
Yuriev, A., Boiral, O., Francoeur, V., Paillé, P. (2018): "Superare le barriere ai comportamenti proambientali sul luogo di lavoro: una revisione sistematica". Journal of Cleaner Production.
Sull'inazione di fronte al cambiamento climatico Robert Gifford, R. (2011): "I draghi dell'inazione: barriere psicologiche che limitano la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico", American Psychologist.